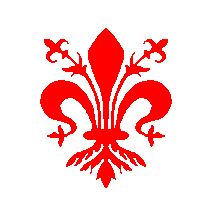
contatti : pierluigi18faber@libero.it
indice generale : http://www.carnesecchi.eu/indice.htm
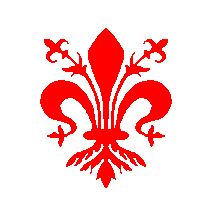
Firenze dal medioevo al novecento
Famiglie iscritte nei libri d'oro della nobilta' di Firenze
Gia' nel secolo XV vi fu una lunga disputa su cosa dovesse intendersi con il termine nobilta'
Nella Firenze repubblicana i titoli nobiliari non esistevano,e si aveva grande sospetto del cittadino a cui un potere straniero avesse concesso un titolo nobiliare per il legame di FIDELITAS tra Fons Honorume e vassallo contrapposti alla lealta' repubblicana
nobilta' , ceto drigente , notabilita' , nobile per pubblica fama , nobilta' diplomata o certificata
Premessa liberamente tratta ( con alcune correzioni ) da :
https://www.tuscany-vacation.us/IT/vacanza_toscana/ville_toscana/famiglie_nobili.html
Ogni stato ha una propria storia e le classi sociali presenti in esso non possono essere spiegate univocamente. Nell'Alto Medioevo il nobile era colui che era vicino al sovrano e che poteva svolgere alcune sue funzioni; in tedesco 'adelig'. Fra i Longobardi coloro che potevano esercitare la sovranità su un territorio erano i duchi, mentre fra i Franchi erano i conti, i marchesi e i missi dominici. Anche se inizialmente questi poteri erano temporanei, col passare degli anni divennero poteri ereditari e si cominciarono a creare quindi famiglie scelte dai sovrani che per più generazioni avevano il diritto di governare un determinato feudo. Fra i nomi illustri ricordiamo I Conti Guidi in particolare nel Casentino, i Conti Alberti di Prato, gli Aldobrandeschi, i Conti della Gherardesca a Volterra, i Marchesi Malaspina in Lunigiana, i Cadolingi di Pistoia, i Conti d'Elci, della Scialenga e della Berardenga a Siena, i Pazzi nel Valdarno, i Ricasoi nel Chianti, gli Ubaldini nel Mugello, ......................
Dal XII secolo in poi si aggiunge un altro modo di diventare nobili: l'investitura cavalleresca. Alla fine del Duecento comincia a crescere il numero di mercanti, banchieri, medici e artigiani che, giunti in città, cominciano a governarla ed ad avere importanti incarichi. Nasce la borghesia che, anche se in principio si contrappone alla nobiltà, col tempo inizia a inserire i propri stemmi e gonfaloni nei registri dei priori e si eleva quindi per meriti economici al rango di nobiltà. Fra questi, i Capponi, Rucellai, Strozzi, Corsini, Aldobrandini, Frescobaldi, Guicciardini, Salviati, Ginori, Torrigiani, Bardi, Acciaioli, Machiavelli, Cerretani, Portinari, Tornabuoni, Vespucci .........................ed ovviamente i Medici.
Firenze comincia a conquistare i territori vicini e le famiglie più vicine ai Medici aumentano il loro potere: Ginori, Pucci e Niccolini............... Nelle ancora indipendenti città di Lucca e Siena si instaurano famiglie i cui nomi sono ancora oggi conosciuti: a Lucca, ad esempio, i Guinigi, i Burlamacchi, i Cenami e i Mansi, mentre a Siena i Salimbeni, i Bichi, I Saracini, i Piccolomini e i Chigi. Con la conquista di Siena da parte dei Medici, in Toscana nasce una nobiltà di corte fedele alla famiglia Medici con componenti sia storicamente toscane che straniere. Ecco i Claini, Grifoni, Ramirez di Montalvo, Suares de la Concha, Ximenes d'Aragona, Viviani della Robbia, Inghirami, Guidi di Volterra, Riccardi e Feroni. Infine va ricordato che l'ultimo granduca toscano, Leopoldo II, concesse il titolo di principe alle famiglie Demidoff e Poniatowsky e di duca ai Marchesi di Rassina Nerli, ma la vita del Granducato di Toscana era ormai finita.
Anche perche' con le nuove idee veicolate dalla rivoluzione francese , il concetto di nobilta' e molti dei privilegi legati al ceto erano destinati a cambiare
Libri d'oro della nobilta' fiorentina
Ferdinando dei Medici sente la necessità di avere un elenco, ( elenco quanto piu' affidabile possibile visto le differenze tra un priorista e l'altro) degli individui e delle famiglie che avevano esercitato uffici di rilievo
(massime quelli della Signoria) durante il periodo repubblicano.
Adotta quindi l'unico criterio possibile , per la storia passata della Repubblica , cioe' quello di considerare nobile chi avesse avuto antenati che avessero occupato le massime magistrature repubblicane
Un'opera finalizzata anche ad appoggiare le provanze di nobilta' per l'ammissione all'ordine di Santo Stefano.
Affida l'incarico di compilare quest'opera a Bernardo Benvenuti
Doveva il Benvenuti vedere e copiare i vari prioristi ufficiali o eruditi compilati fino ad allora , al fine di costruirne uno nuovo ; la fonte primaria da utilizzare era indicata nel "Priorista fiorentino" di Francesco Segaloni del 1625 (ASF Manoscritti Filza 226 ).
Il lavoro del Benvenuti fu lungo e complesso , tanto che , morto il Benvenuti , nel 1708 l'impresa fu proseguita da Lorenzo Maria Mariani, che dette compimento all'ultimo volume nel 1722
Iò principio adottato escludeva dal riconoscimento della nobilta' le famiglie magnatizie che a causa degli ordinamenti di giustizia erano state private del diritto di partecipare agli scrutini alla massime magistrature repubblicane ed escludeva anche le grandi famiglie ghibelline e pure escludeva le famiglie consolari
Cancellava di fatto la storia fiorentina prima del 1282
La prima legge sulla nobilta' pero' si aveva solo sotto i Lorena .
Per la cortesia del conte Massimo Angelo Cavalloni
TRE NOBILTA' della dressa Marcella Aglietti
Questa legge non solo non sanava i difetti della "legge medicea " ma anzi la peggiorava legando l'appartenenza alla nobilta' anche a criteri patrimoniali : chi era sotto una certa soglia patrimoniale non poteva appartenere alla nobilta' qualunque fossero i meriti dei suoi antenati
Questo spinge il Mecatti a scrivere :
Da Giuseppe Maria Mecatti : " Storia genealogica della nobilta' e cittadinanza di Firenze "
Lo stampatore a chi legge
Perche' , in vigore di una certa Legge promulgata , che non e' gran tempo in Firenze , in cui si dispone della Nobilta', e Cittadinanza Fiorentina , e si conchiude , che non saranno ammessi alla Cittadinanza , se non coloro , i quali avranno dieci fiorini a decima ; e resteranno per grazia speciale nella borsa de' Cittadini coloro , i quali saranno antichi , ma che avranno al presente sei fiorini a decima ; e coloro i quali non avranno questi sei fiorini non ostante la loro antichita' , ed i loro fin ad ora goduti onori , saranno cavati fuori da dette borse, e saranno accomunati colla plebe , e col volgo ; e si danno anche varie altre Leggi per dividere in due classi la Nobilta' Perche' (dico) in vigore di questa Legge puo' addivenire che molte casa Nobili e Cittadinesche per mancanza di beni di fortuna , o non lo siano piu', o non lo siano in quel grado , che veramente loro competeva , mediante la loro vera Nobilta' e antichita' onde coll'andare del tempo , promulgata , che sia questa nuova legge si sperdano di loro memorie ; un certo Nazionale Fiorentino mio Amico , temendo , che non sia per accadergli un tale infortunio ; perche' fornito di beni di fortuna ei non e' troppo ; credendo di far beneficio ad altri suoi Nazionali , i quali si troveranno forse nel medesimo caso di lui ; avendo presso di se varie notizie Istoriche Genealogiche , tanto edite , che inedite , me le ha partecipate ; e parendomi queste buone , perche'rimanga alla memoria della posterita'il grado , e condizione di tutte le Famiglie , alle quali prima che detta Legge fosse eseguita , niuno ha mai potuto contrastare la loro Nobilta', e Civilta' , la quale per difetto di facolta', e di sostanze pare strano , che ora abbiano da perdere; le ho volute dare alla luce colle mie stampe . In virtu' adunque delle medesime apparisce chi siano veramente , e realmente i piu' , o i meno Nobili , e in che tempo , e in che maniera ei siano Nobili addivenuti. …………………………………………………………………………………..
Cosi' potranno consolarsi quelle famiglie le quali si vedranno notate in questo Priorista , se decadute sono presentemente , e mancanti di beni di fortuna ; mentre che tutto il Mondo fara' loro giustizia , che benche' povere ; sono pero' nobili e antiche , e in conseguenza degne di tutta la considerazione ; non essendo al parere dei piu' savi le sole ricchezze quelle , che costituiscono le Famiglie nobili, e grandi.
………………………………………………………elenca le famiglie che hanno goduto l'appartenenza ai Tre Maggiori………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
-------------------------------
Francesco Stefano il primo granduca della dinastia lorenese riceve l'investitura della Toscana con diploma imperiale del 24 gennaio 1737; destinato ad affiancare la moglie alla testa della monarchia asburgica (prima coreggente della stessa, verrà poi eletto sacro romano imperatore nel 1745), affida il governo della Toscana a una reggenza presieduta da Marc de Beauvau, principe di Craon, compiendo una sola visita nella regione (1739).
La Toscana, divenendo di diritto e di fatto un feudo dell'impero, è in questi primi anni una pertinenza politica ed economica della corte di Vienna. Il celebre mecenatismo dei Medici con le loro numerose e famose committenze, improvvisamente cessa: anzi il nuovo granduca ereditando le vaste e cospicue proprietà medicee, fa incetta delle imponenti collezioni raccolte nel corso dei secoli. In occasione della visita di Francesco Stefano a Firenze, vengono trasferite a Vienna numerosissime opere d'arte dei palazzi medicei, con una lunga processione di carri che per tre giorni escono da Porta San Gallo.
Ottobre 1757 Legge sulla nobiltà, viene istituito un registro della nobiltà e della cittadinanza.
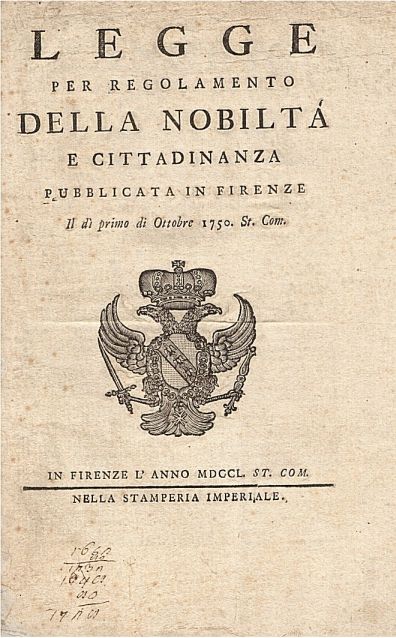
Per levare ogni dubbio circa allo stato delle persone, e distinguere chiaramente tra i nostri fedeli sudditi i veri Nobili, ai quali solamente nella nostra Legge sopra ifidecommissi e primogeniture è piaciuto a noi permettere in avvenire l’instituzione, e per altri giusti motivi ancora, di nostra certa scienza, e colla pienezza della nostra su prema potestà determiniamo e diamo osservarsi rispetto alla nobiltà e cittadinanza di questo nostro Gran-Ducato i seguenti ordini. ( Motup. 31. Luglio 1750. in princ. )
1.Riconosciamo Nobili esser tutti quelli che posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà pei diplomi nostri o de’ nostri antecessori, e finalmente la maggior parte di quelli che hanno goduto o sono abili a godere presentemente il primo e più distinto onore delle Città nobili loro patrie, e Cittadini quelli che hanno o sono atti ad aver tutti gli ordini delle Città, fuori che il primo. Perciò ordiniamo che nelle nobili Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, S. Sepolcro, Montepulciano, Colle, s. Miniato, Prato, Livorno, e Pescia le enunciate nobili famiglie si registrino per tali pubblicamente in un nuovo libro a parte, e che le rimanenti ammesse a tutte le borse, fuori che alle prime, restico scritte come avanti per Cittadini ai libri pubblici, nel modo e forma, e coi requisiti sotto espressi (d. Art. 1.)
2. Nelle prime 7. antiche Città di Firenze, Siena, Pisa , Pistoja , Arezzo, Volterra, e Cortona, vogliamo che tal descrizione di nobili si faccia distinta in due classi, alla prima delle quali diano il nome di nobili Patrizj, all’altra quello solo di nobili. .............
3. E nelle 7. rimanenti Città meno antiche comandiamo che si scrivano per ora tutti i nobili indistintamente sotto l’unica classe della nobiltà. Riservando a Noi ed ai nostri successori GranDuchi di graziare a suo tempo benignamente esse ancora della distinzione del Patriziato. (d. Art. 3. )
4. Dichiariamno che le rimanenti Città del nostro Granducato quivi non espresse non possono avere il rango nobile, per esservi nelle medesime, attesa la poca popolazione, stati am inessi senza alcun riguardo al godimento del primo onore tutti gli abitatori più benestanti. ( d. Art. 4. )
5. Tra le famiglie nobili delle respettive antiche Città ordiniamo nella classe de’ Patrizj si descrivano tutte le famiglie nobili di cui sono state ricevute le provanze per giustizia al nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili, che in virtù di qualunque altro requisito enunciato nell’Art. 1. proveranno la continuazione della propria nobiltà per lo spazio di anni 200. compiti. ( d. Art. 5. )
6. Nella classe de’nobili nelle nominate antiche Città vogliamo che si registrino tutte le famiglie discendenti da soggetti ricevuti nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le altre famiglie nobili, che non potranno concludere le loro prove pel sopra sta bilito corso di tempo. Nelle altre 7. meno antiche Città, ove non è che la classe de’ nobili, ordiniano che vi si scrivano indistintamente tutte le famiglie nobili ammesse nel nostro Ordine di S. Stefano, e tutte le rimanenti famiglie per qualsivoglia altro giusto titolo, come sopra capace di provare la loro nobiltà. I nativi delle altre Citta, Terre, o Luoghi del nostro Granducato, che fossero già ricevuti, o si riceveranno in avvenire nel nostro Ordine di S. Stefano, o veramente fossero stati, o saranno per diplomi nostri, o de Gran-Duchi nostri antecessori, crcati nobili, si registrino nella classe della nobiltà della Città fra le sopra espresse la più vicina al luogo della loro origine o abitazione ; non potendo per altro esercitare le Magistrature, se prima non vi paghino le gravezze, o vi acquistino il domicilio a tenore delle Leggi veglianti, degli statuti locali, e della consuetudine. ( d. Art. 6. )
7. Tutte le soprannominate famiglie e persone comandiamo che siano ammesse alle respettive classi dei Patrizj, e dei nobili, purchè mantengano presentemente col dovuto splendore la nobiltà loro trasmessa dai loro antenati, escluse assolutamente quelle che hanno derogato alla medesima per l’esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa di cui si faccia menzione più sotto all’Art. della perdita della nobiltà. (S 31. segg.) (d. Art. 7.)
8. Delle famiglie e persone ammesse da 50. anni in quà ai primi onori delle Città soprannominate non intendiamo riconoscere per nobili, e perciò ordiniano che non si registrino nella classe della nobiltà, se non quelle, che, acquistatovi il domicilio, ed imparentatesi nobilmente, posseggono nel comune delle medesime Città , o altrove, tanti effetti e beni da poterne colle rendite viver decorosamente, e stabilire in tal forma la nobiltà nuovamente acquistata, o che ne abbiano ottenuto o ne otterranno da noi una special grazia. (d. Art. 8.)
9. Nel nostro Archivio di Palazzo in Firenze, detto già delle Riformagioni, sarà fatta avanti i Deputati la pubblica descrizione delle due classi dei Patrizi e dei nobili, coi dovuti esami e riscontri delle domande e recapiti ammissibili, secondo la nostra istruzione pubblicata in questo stesso giorno. ($ 39. segg. ) (d. Art. 9.)
10. All’effetto di far la nuova descrizione, ordiniamo a tutti i capi delle case nobili fiorentine, che a tenore dei medesimi hanno da essere scritti colle loro famiglie nell’una o nell’altra classe, di presentare nel detto Archivio di Palazzo ai Deputati le loro domande coi loro documenti autentici ed in buona forma ; quali documenti e domande parimente vogliamo che in Siena si esibiscano avanti il nostro Auditor generale di quella Città , e nelle restanti Città sopra espresse avanti i respettivi loro Giusdicenti. Questi, compiti i comandati riscontri ai libri esistenti sul luogo, rimetteranno tutto immediatamente ai Deputati sopraddetti, nel modo e forma ordinata loro in detta nostra istruzione. (d. Art. 10.)
11. Terminati poi i registri originali del patriziato e della nobiltà, che debbono sempre conservarsi nell’Archivio di Palazzo, incarichiamo il nostro Segretario di Stato di farne fare immediatamente le copie, e sottoscritte di sua mano, e munite del nostro imperiale sigillo, mandarle in ciascheduna delle respettive Città per ivi tenersi negli Archivj di esse. . Art. 11.)
12. Ogni volta che nascerà un figliuolo o figliuola legittimo e naturale in alcuna famiglia patrizia o nobile, sarà cura del capo di casa di farlo prontamente scrivere in queste copie, portandone perciò al Giusdicente la fede autentica del battesimo, o sivvero potrà inviarla a Firenze nell’Archivio di Palazzo, affinchè ivi sia scritto subito nel libro originale, è dato l’ ordine per farlo notare dipoi anco nel libro della sua patria. (d. Art. 12.)
13. Comandiamo espressamente all’Auditore generale di Siena, e a tutti gli altri Giusdicenti delle sopra nominate Città, di rimettere in Firenze alla fine di ogni anno la nota dei nat? fatti da loro descrivere nei registri, colle filze delle fedi del battesimo, facendo consegnar tutto in mano del Segretario di Stato, o nell’Archivio di Palazzo, acciò siano scritti parimente nei respettivi originali registri ivi esistenti. Tanto ancora si osserverà dai capi delle famiglie nobili fiorentine nel portare all’Archivio di Palazzo le fedi delle nascite per far descrivere la loro prole legittima e naturale ai registri della propria classe. (d. Art. 13.)
14. Riconosciamo i descritti in tal forma nei registri del patriziato e della nobiltà pei soli nobili del nostro Granducato; ai quali solamente, oltre alle altre prerogative e privilegj soliti , intendiamo di aver concesso ultimamente quello di potere instituire le primogeniture e fidecommissi. Nè i Patrizj avranno altra prerogativa di più dei nobili che la sola precedenza sovra di essi in tutte le pubbliche adunanze e funzioni. ( d. Art. 14.)
15. Da ciascuno di questi registri eleggeremo noi ogni anno per turno nella Città di Firenze e Siena otto soggetti, e nelle altre Città sei, la metà sempre delle respettive classi del patriziato, col titolo di Nobili rappresentanti il corpo della Nobiltà della loro patria. Questi Nobili rappresentanti assisteranno ed informeranno in ogni affare concernente la materia della nobiltà della loro patria il nostro Segretario di Stato, e saranno in ogni tempo i testimonj da esaminarsi dai Cavalieri assistenti in occasione di provanze pel ricevimento di qualunque persona agli Ordini nobili; e in caso che tra essi vi fosse alcuno parente del pretendente, o interessato altrimenti in causa , permettiamo allora sì al Segretario di Stato che ai Cavalieri deputati di servirsi in luogo di quello di altro soggetto eletto a loro piacimento dalla respettiva classe. ( Ivi )
– Concediamo loro per ispecial privilegio di cuoprire e sedere avanti qualunque anco supremo Magistrato delle Città, e vogliamo che sia di loro privativa incombenza, esclusivamente ad ogni altro, di far l’ufficio di Paciarj: con intromettersi a fare aggiustamenti tra nobili e nobili, o tra nobili e persone d’inferiore condizione, quando però l’affare o di sua natura, o a richiesta delle parti interessate , non debba terminarsi giuridicamente avanti il Magistrato ordinario. ( Ivi )
– Nella Città di Firenze, in tutte le pubbliche funzioni, ove assista il nostro R. Consiglio di Reggenza, dovranno essi essere immediatamente al di lui seguito in abito di gala avanti i Magistrati, anco del Supremo di detta Città. ( Ivi ) (a) (a) I ranghi e le precedenze oggi vengono regolate da Ordini e consuetudini , per lo più, locali.
– E parimente in tutte le pubbliche funzioni della Città di Siena e delle restanti nobili Città del Gran-Ducato, nelle quali intervenga tutto il corpo delle Magistrature, dovranno eglino, messo nel primo luogo l’Auditor generale, o altro respeltivo Rettore, avere il passo avanti il Gonfaloniere, o altro primo Magistrato della propria Città, quale seguiterà di poi a precedere tutti gli altri Magistrati secondo il consueto; non ostante qualunque ordine, privilegio sì nostro che de’ nostri antecessori Gran-Duchi, legge, o consuetudine immemorabile in contrario : alle quali cose tutte di nostra certa scienza e colla pienezza della nostra su prema potestå deroghiamo in questo capo solamente. ( Ivi)
– L’attuale esercizio di Rappresentante nobile eletto da Noi non darà divieto a veruna Magistratura, di cui starà sempre in arbitrio del Rappresentante medesimo l’accettazione ; purchè in ogni caso di pubbliche funzioni come sopra, lasciato per quella volta il luogo del suo Magistrato, vada cogli altri Rappresentanti nobili al suo posto; volendo Noi espressamente che l’attual godimento di nobile Rappresentante, o la capacità di essere eletto per trovarsi descritto nei respettivi Registri, s’intenda da qui in avanti ad ogni effetto ‘il primo e più distint’onore delle Città nobili, e proprio solo delle nobili, famiglie. ( Ivi)
– I Registri di questi Rappresentanti nobili che si eleggeranno di tempo in tempo da Noi e dai nostri successori, si terranno a parte nell’Archivio di Palazzo a perpetua memoria , e di lì parimente ai suoi tempi si spediranno in esecuzione dei nostri ordini le lettere della fatta elezione in ciascuna Città. ( Ivi )
16.Tutti gli altri nostri fedeli sudditi non descritti in questi Registri dichiariamo non essere nè doversi riputar nobili, non ostante qualsivoglia sentenza, privilegio, godimento di onore, o consuetudine, che si pretendesse allegare; alle quali cose tutte di nostra certa scienza e colla pienezza della nostra suprema volontà deroghiamo in quanto faccia di bisogno. (d. Art. 16. ).
Bruno Casini I Libri d'oro delle citta di Pontremoli e Modigliana
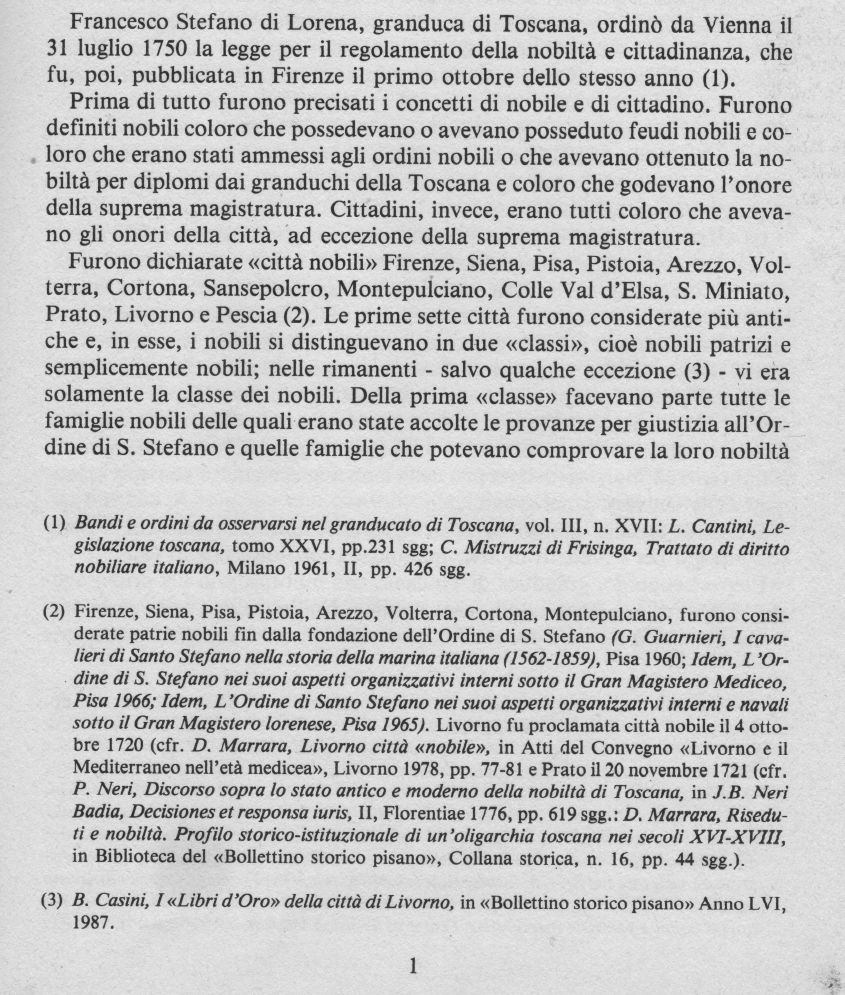
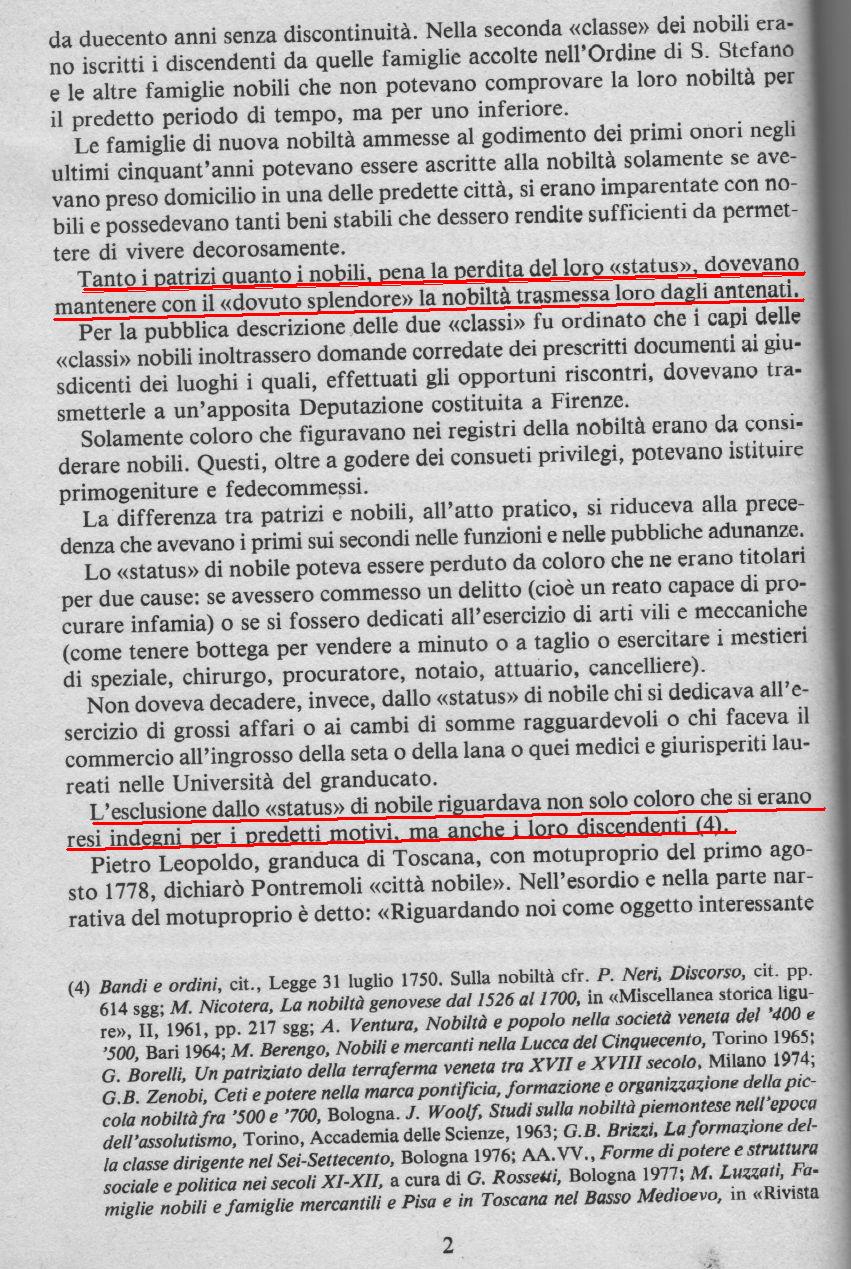
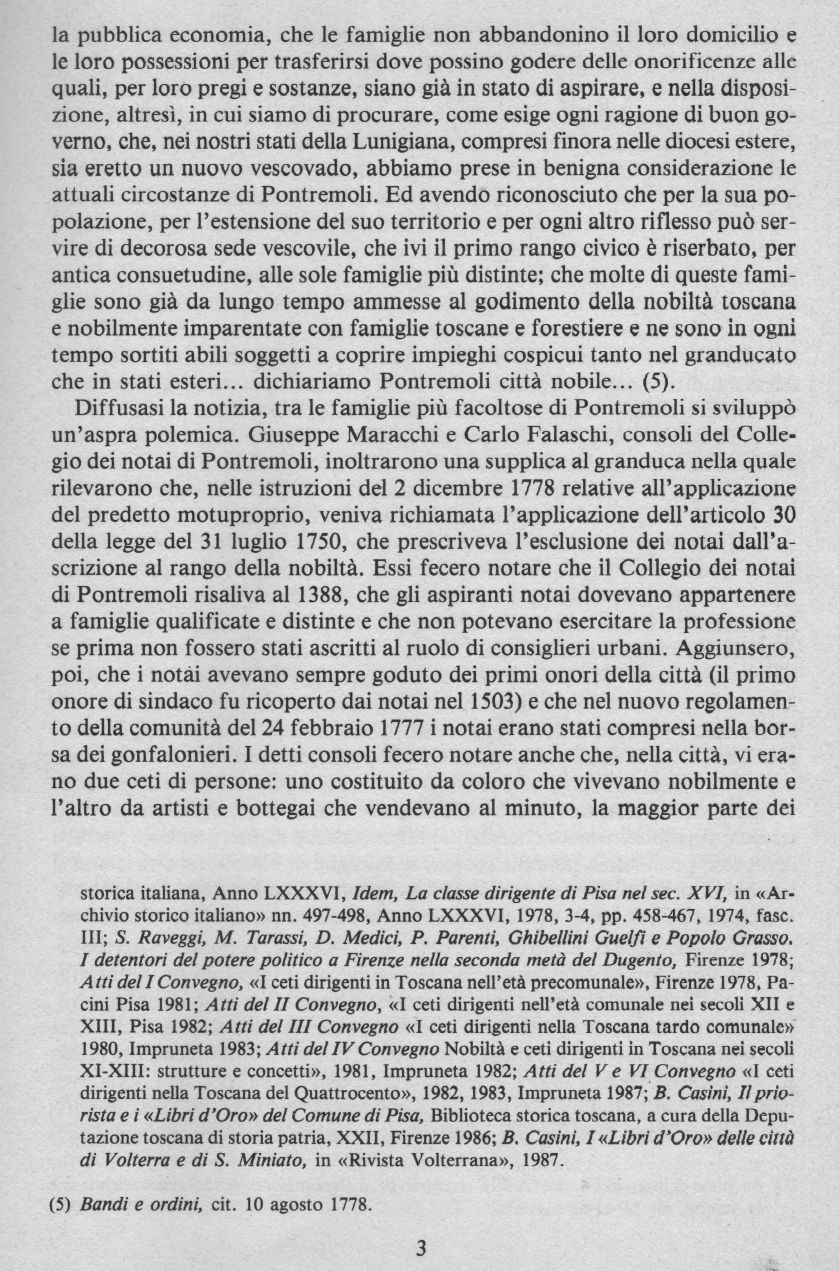
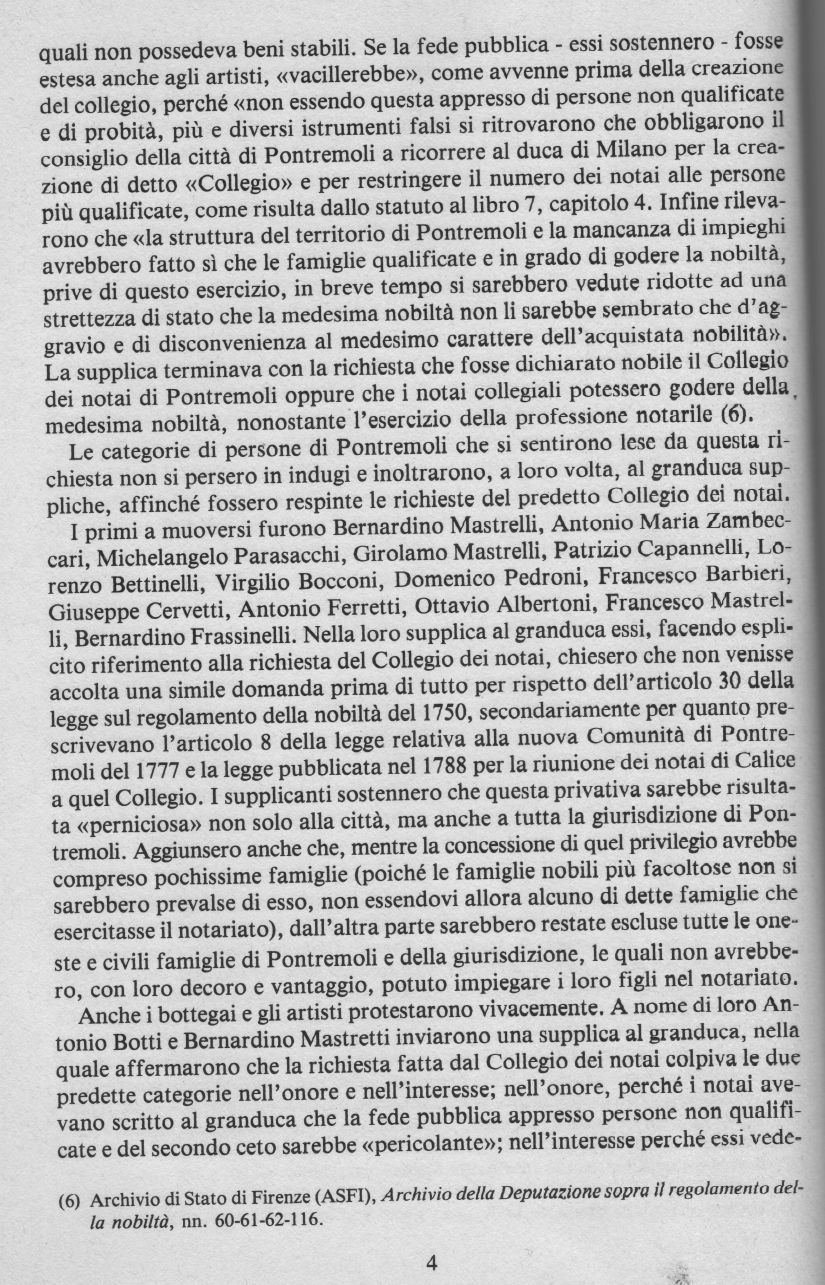
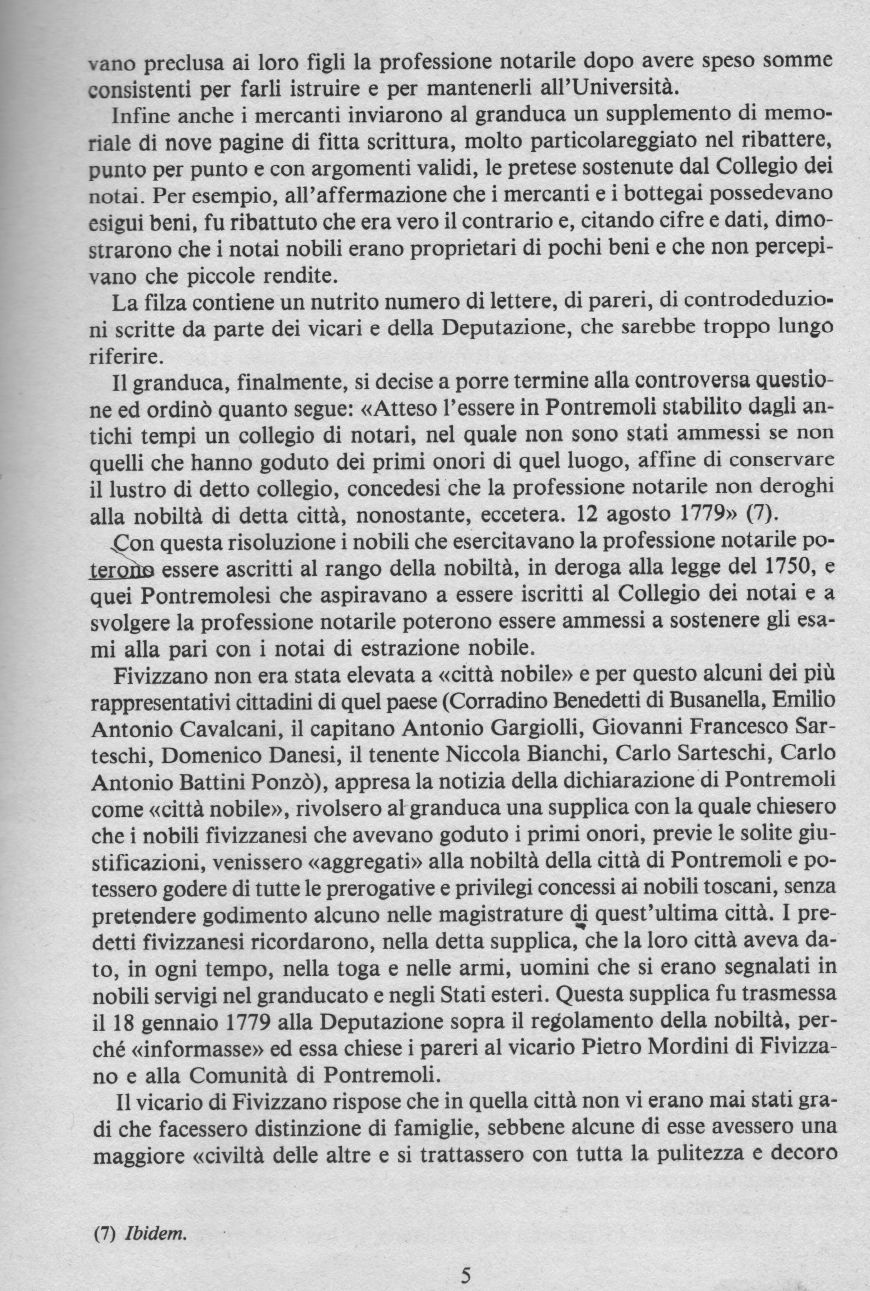
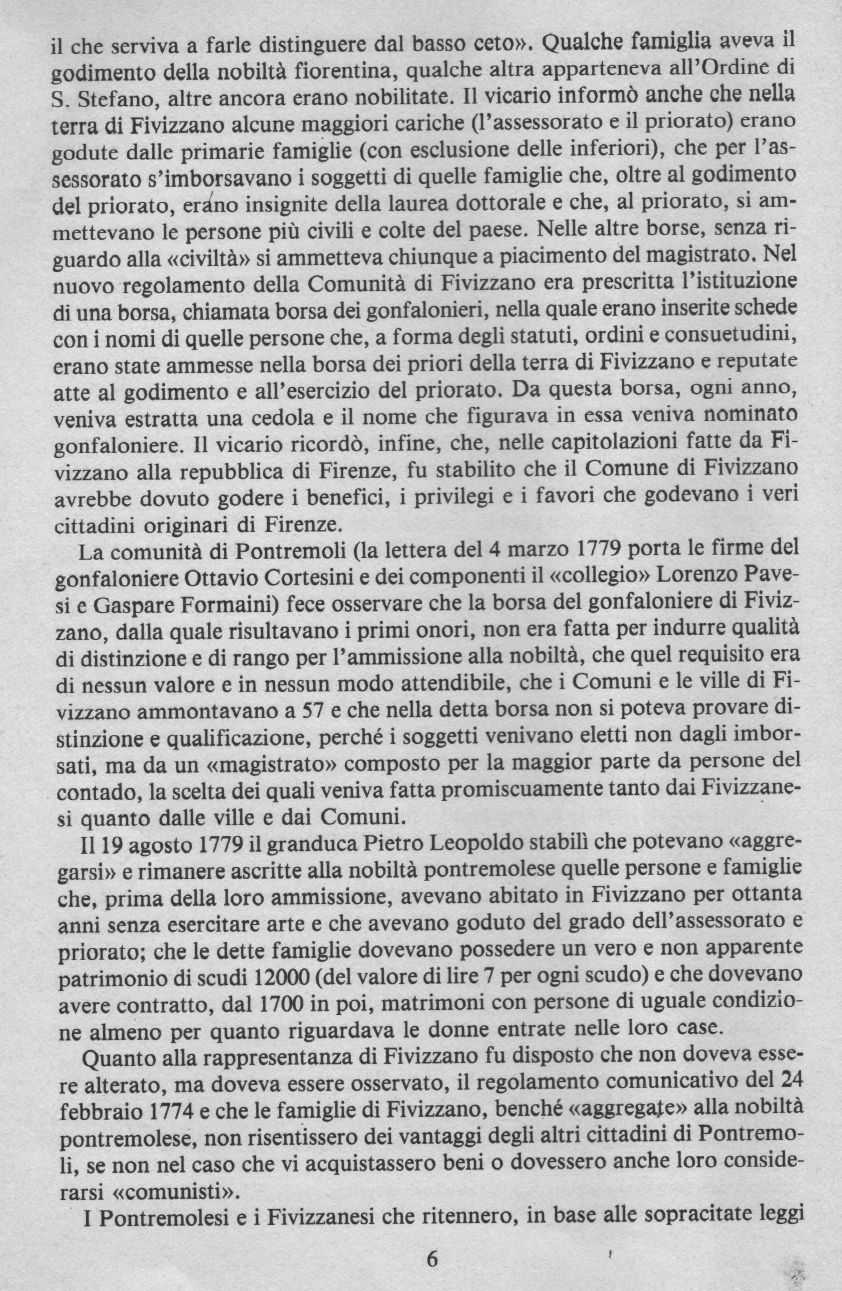
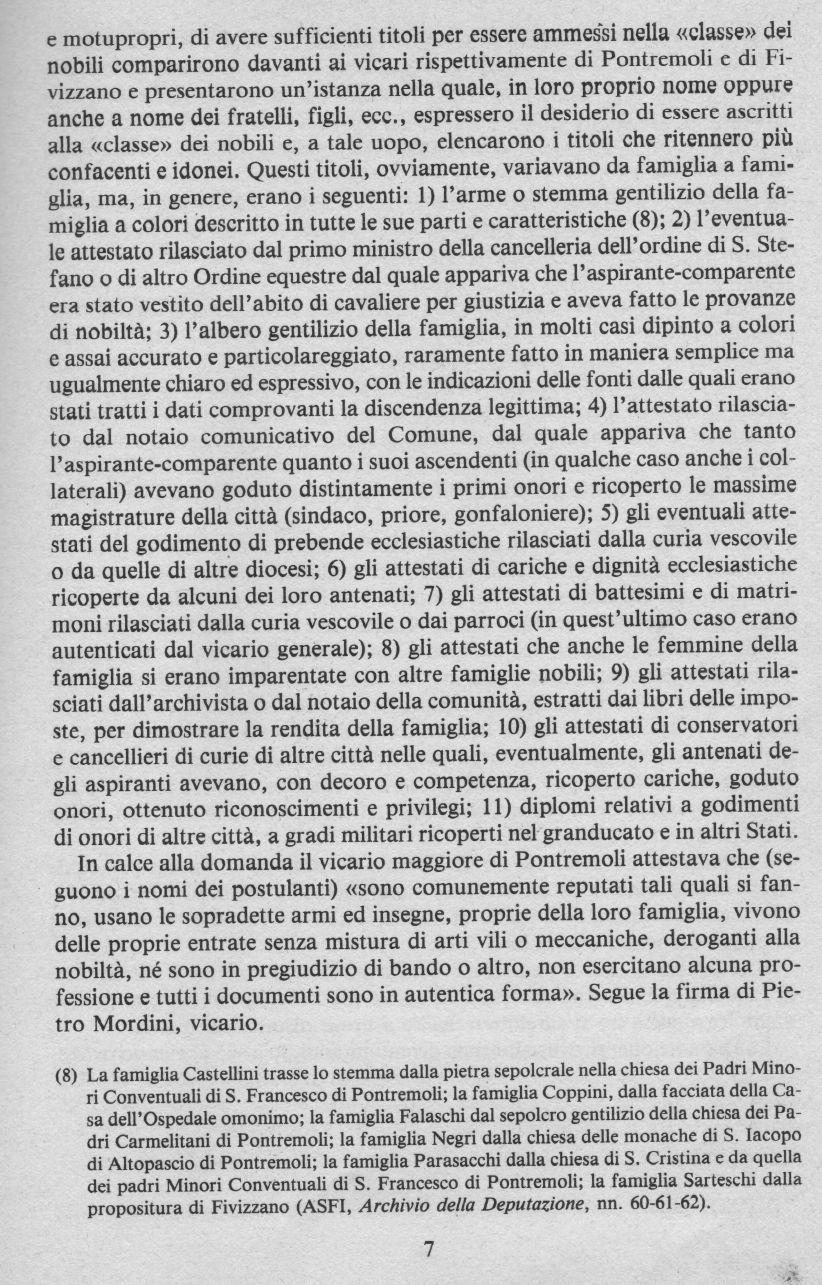
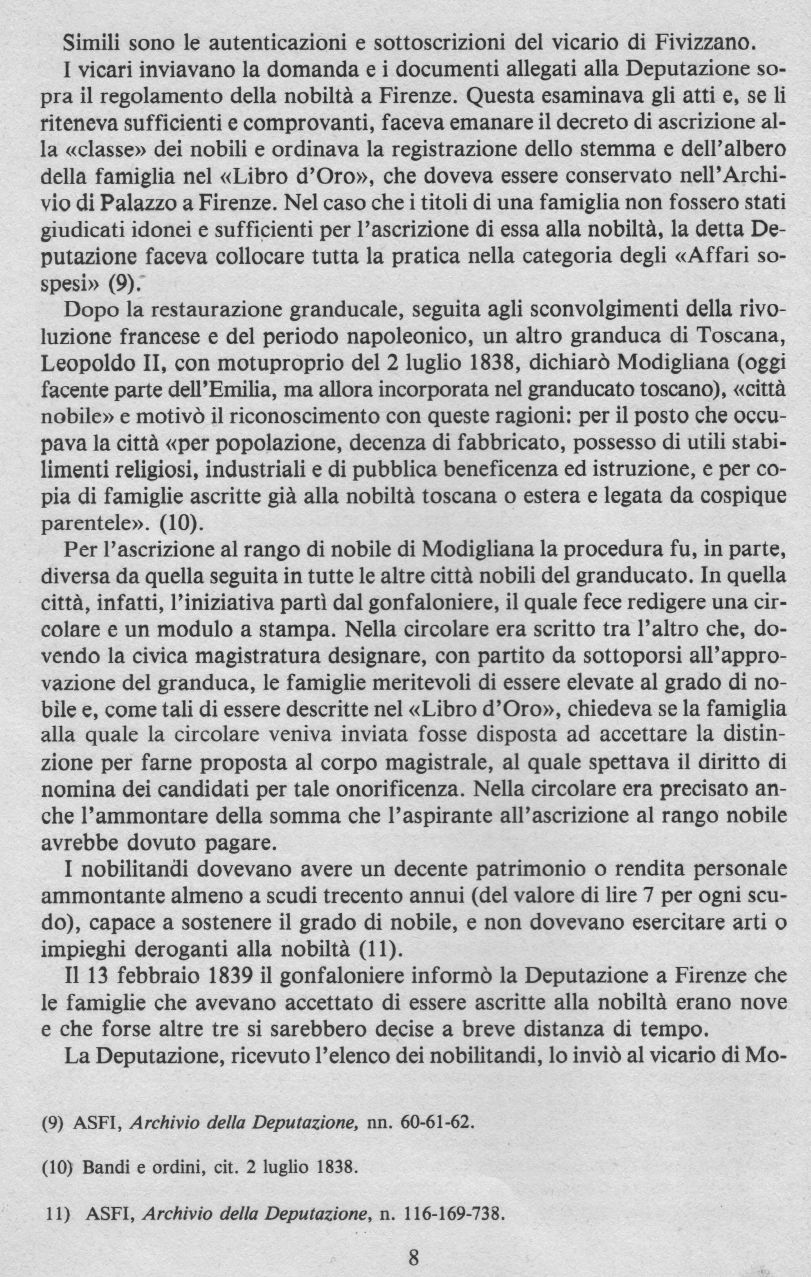
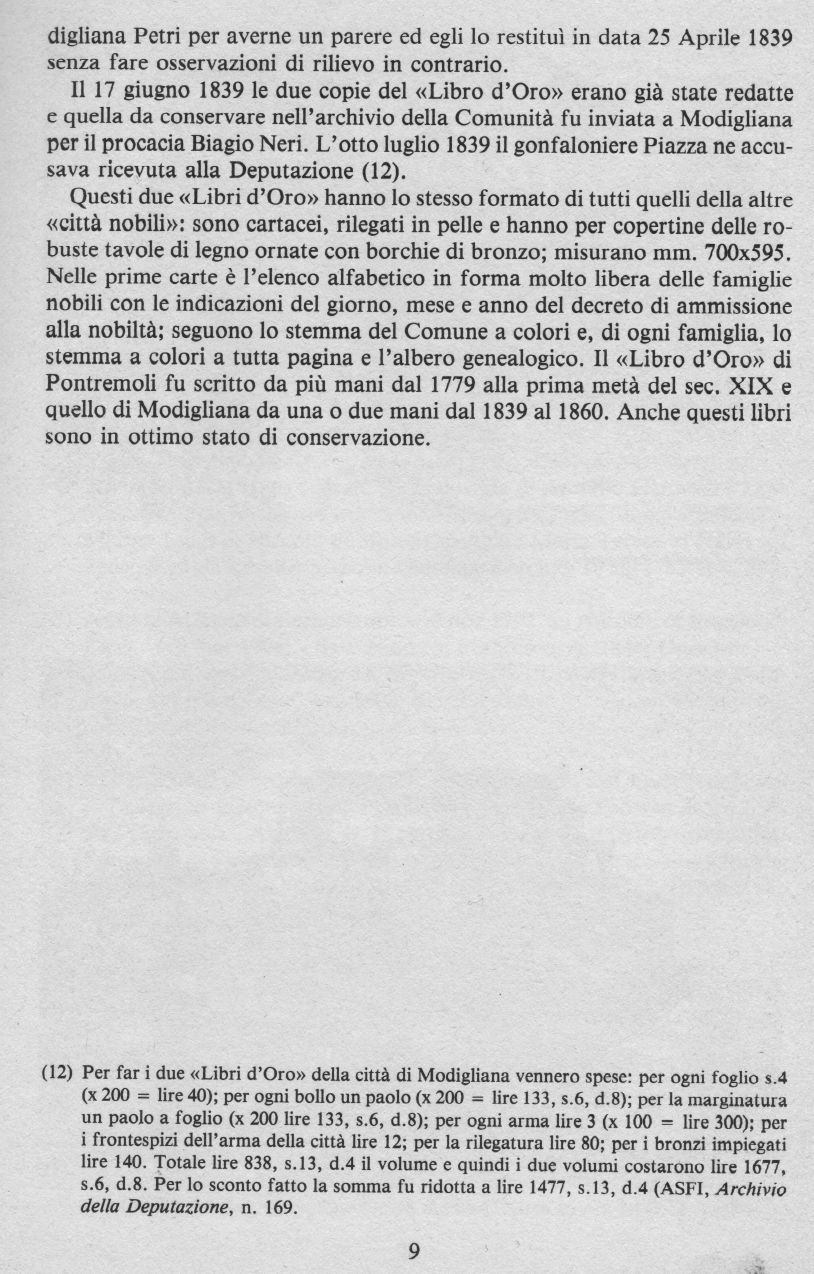
Bruno Casini I Libri d'oro delle citta della nobilta' fiorentina e fiesolana
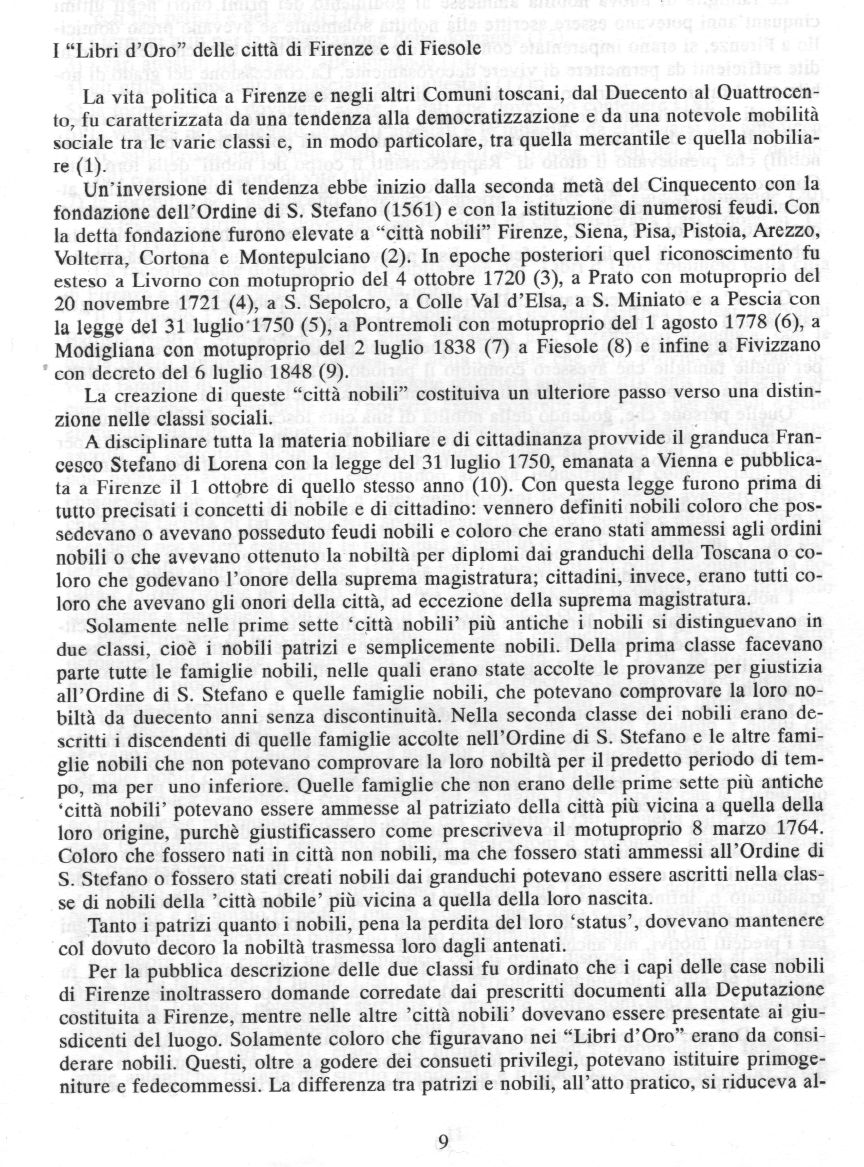
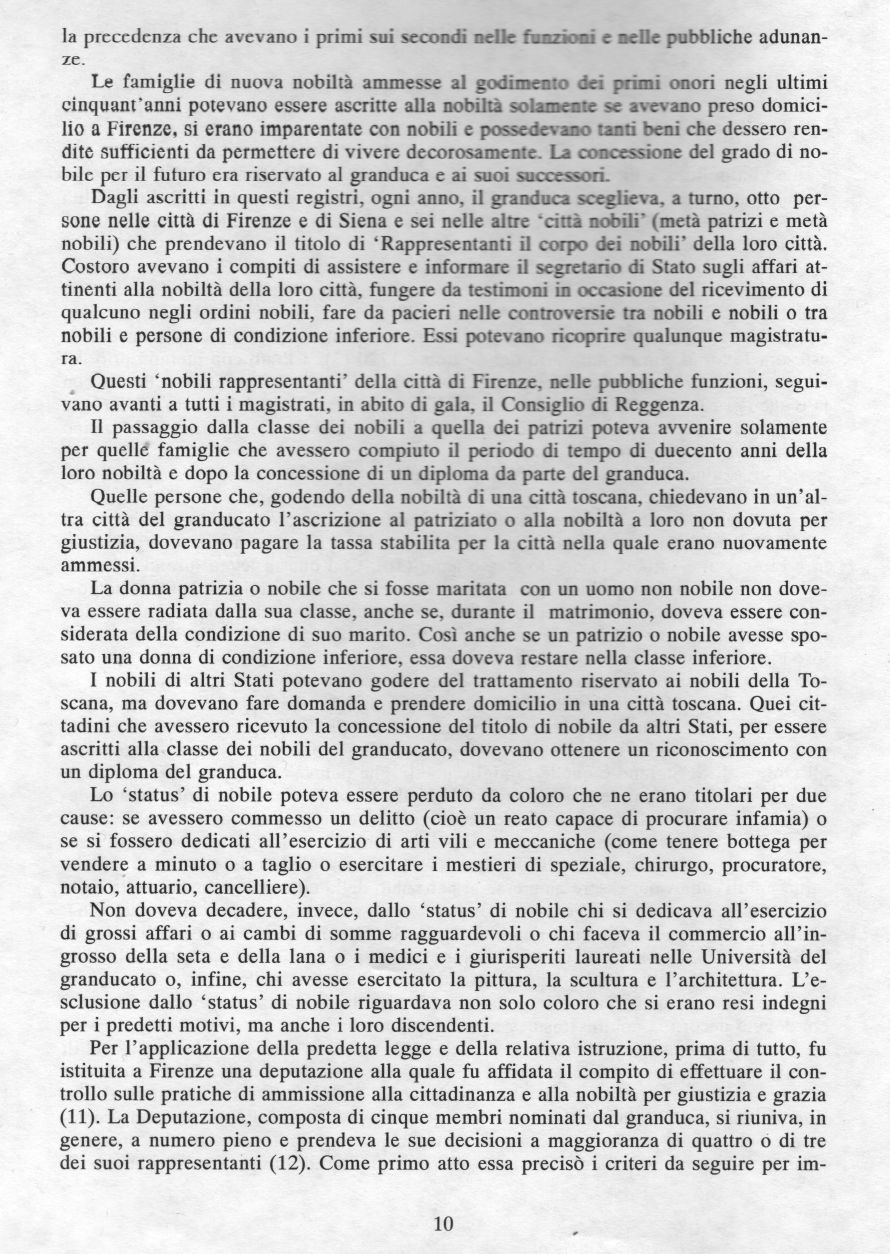
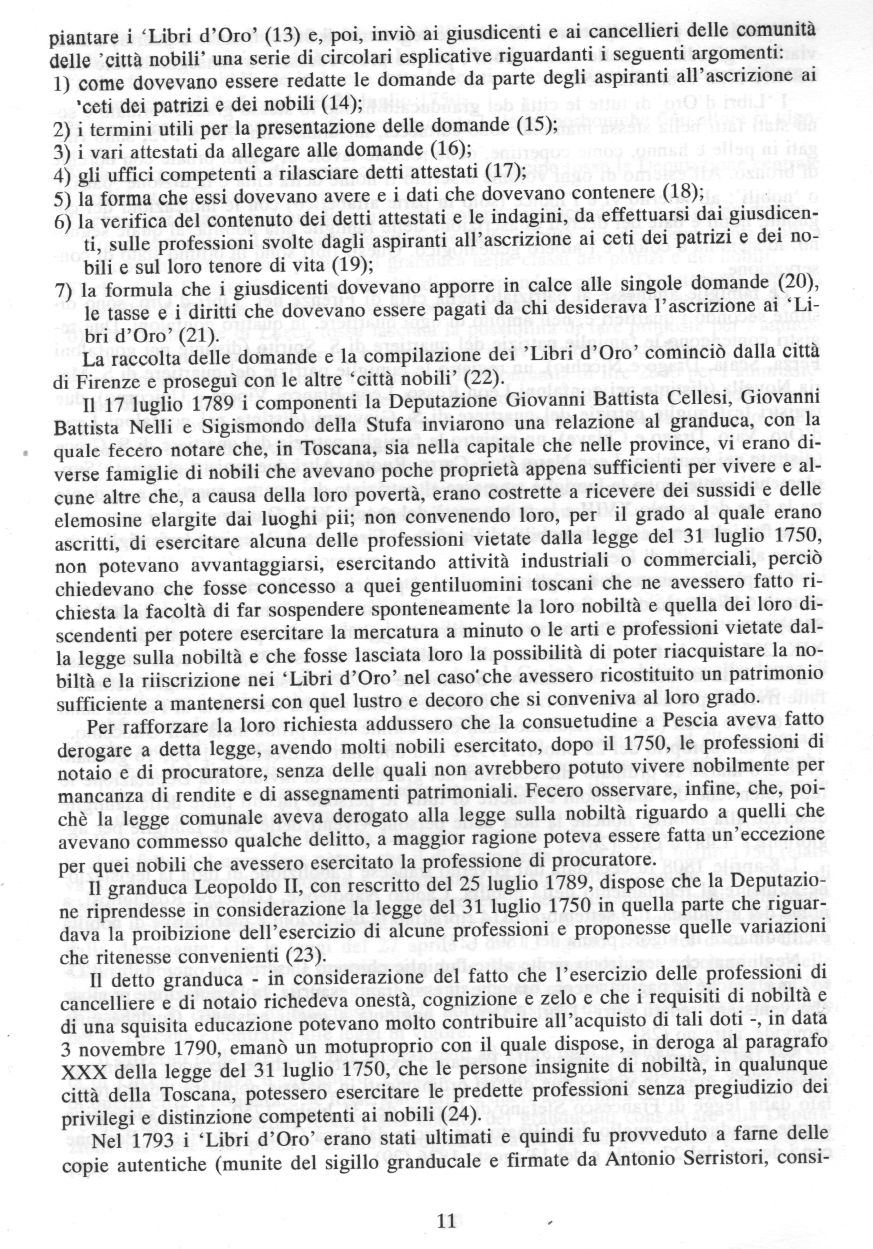
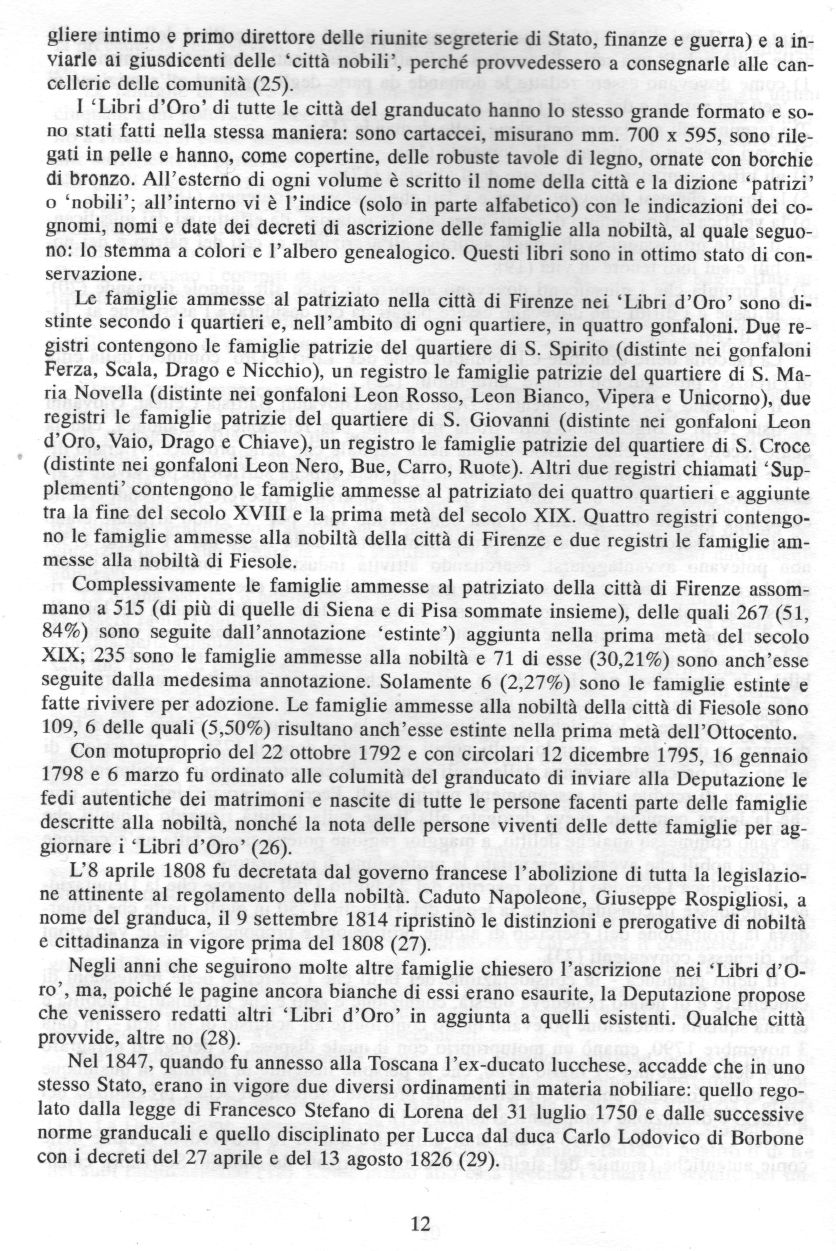
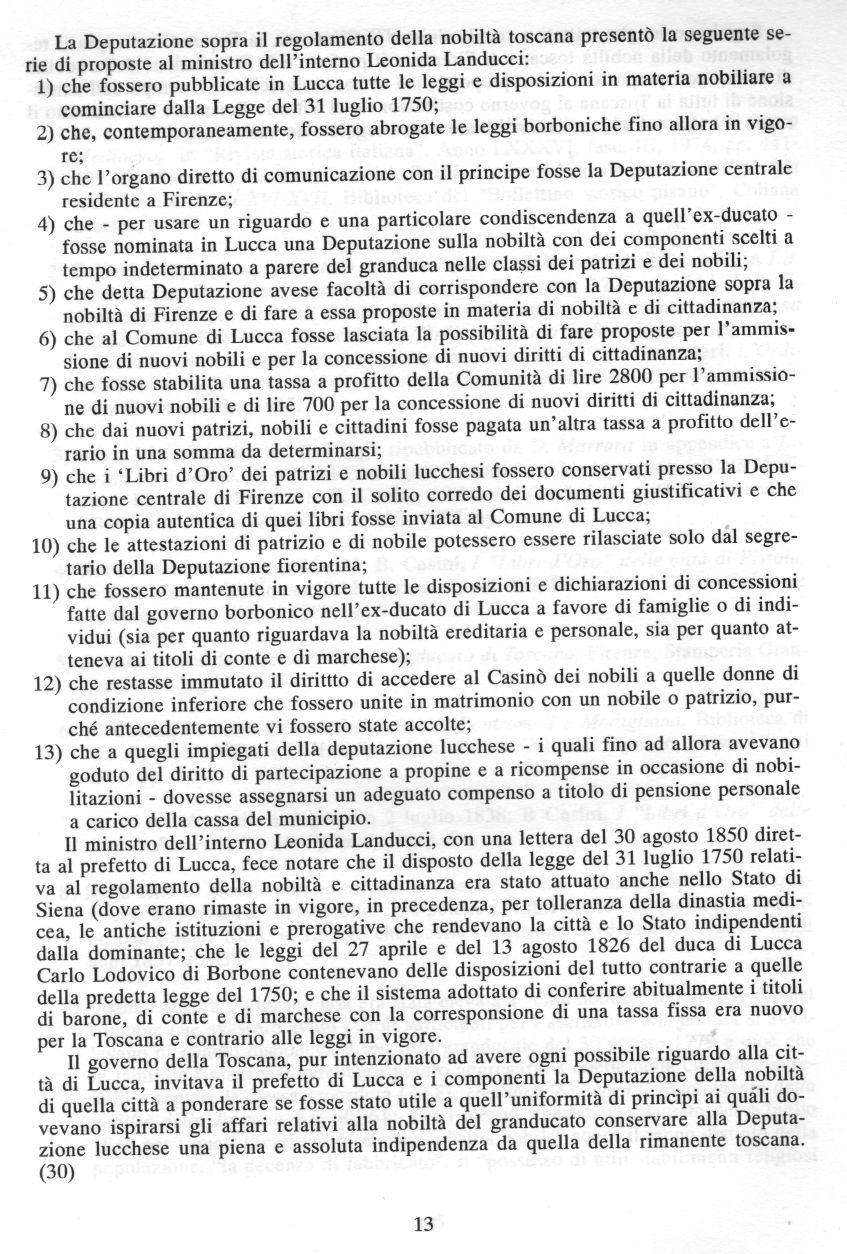
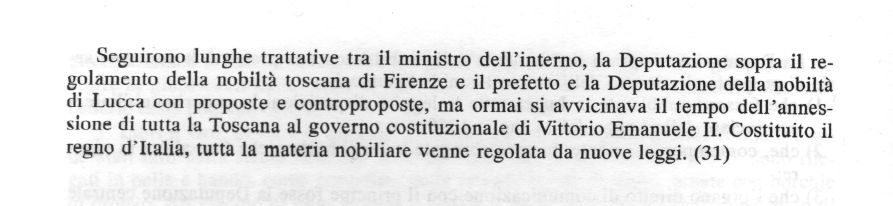
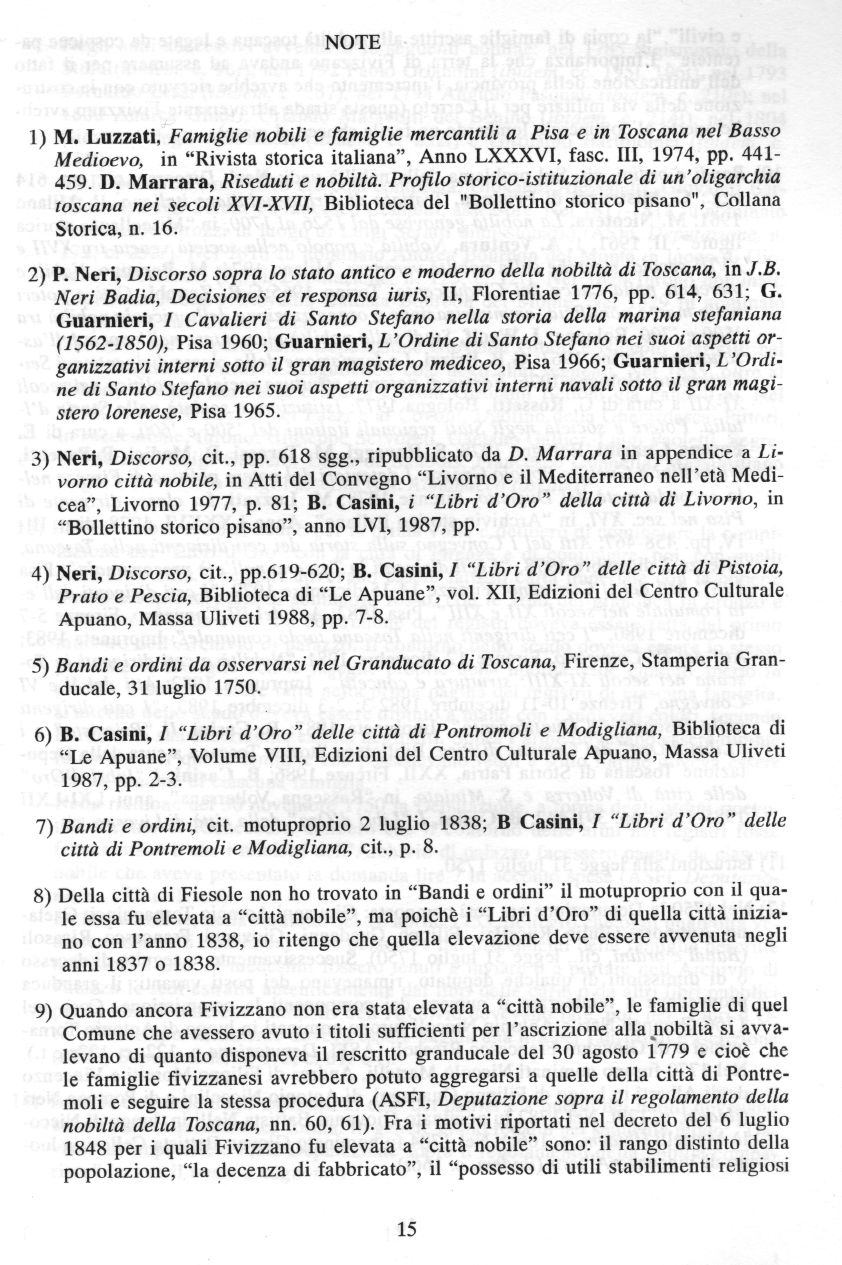
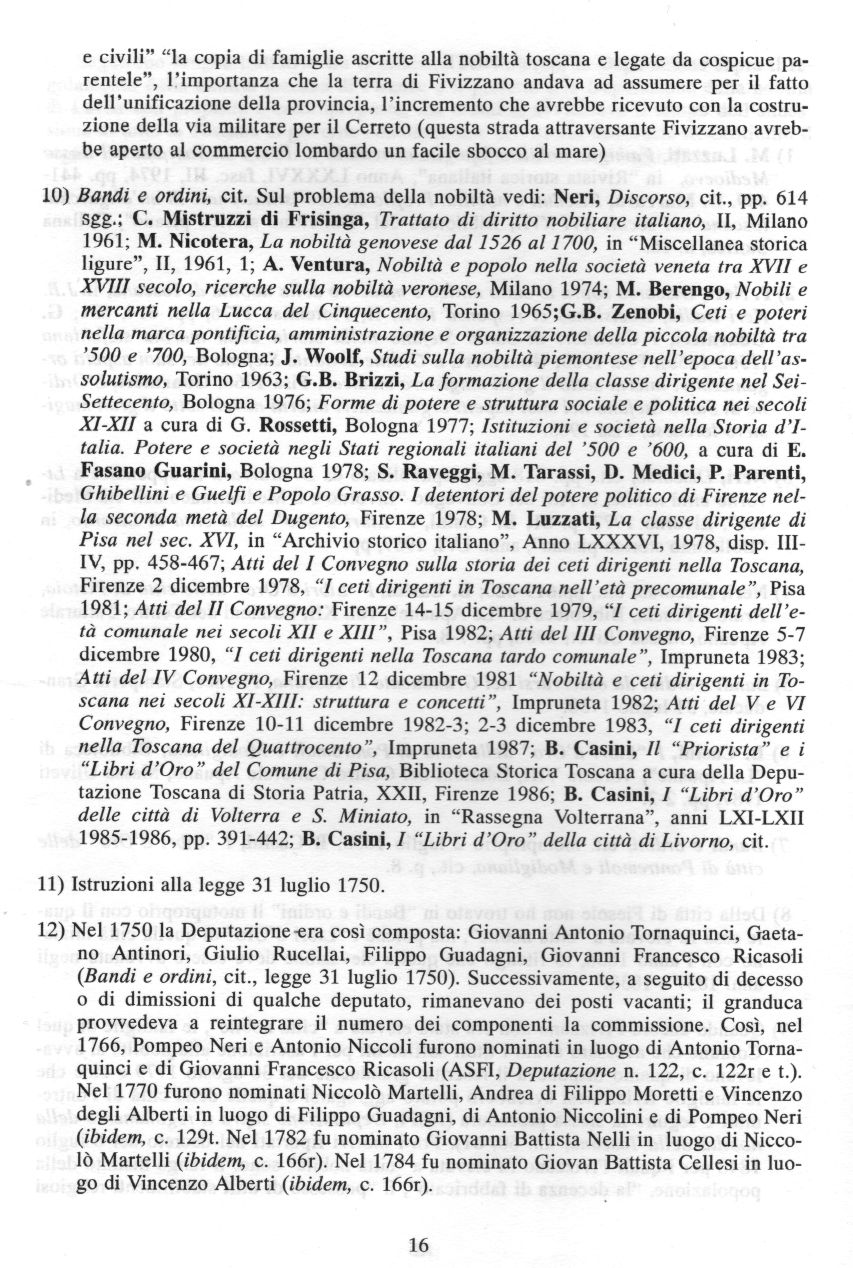
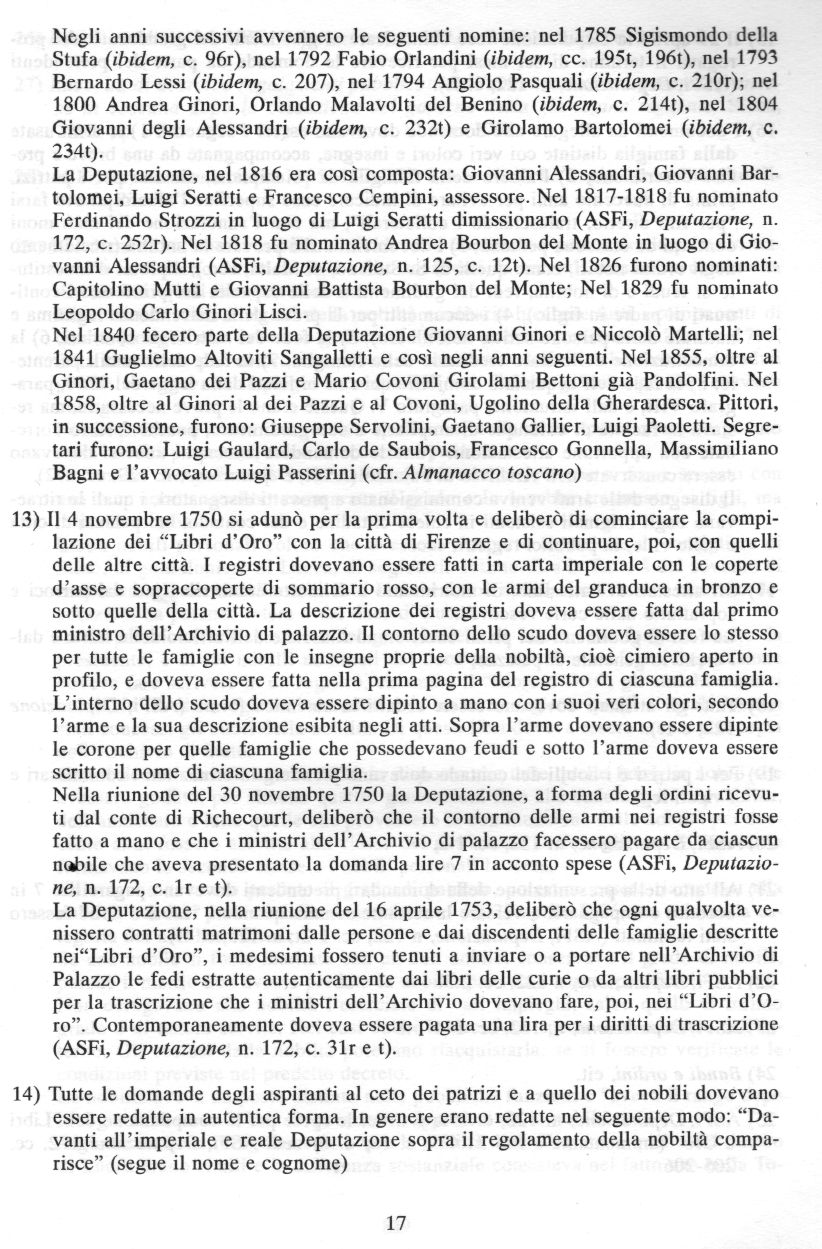
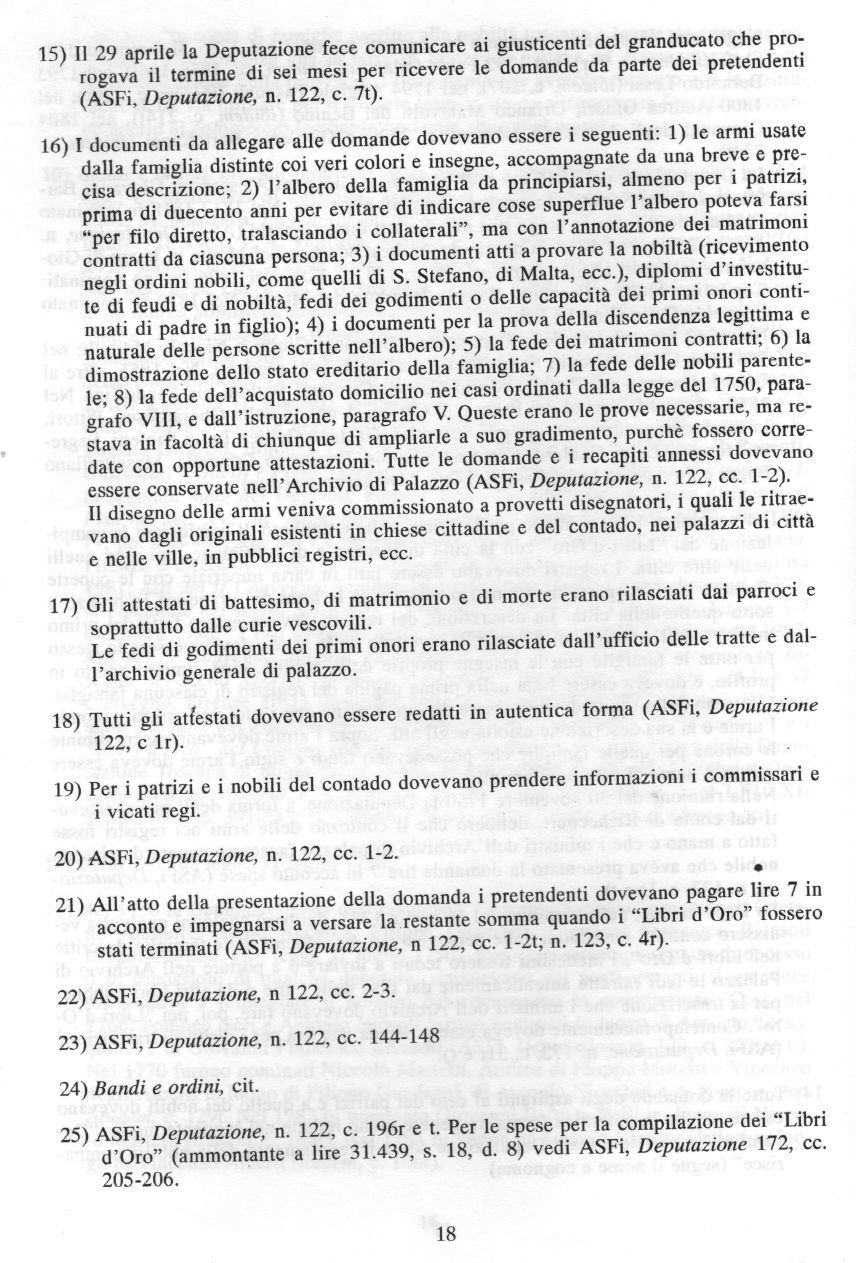
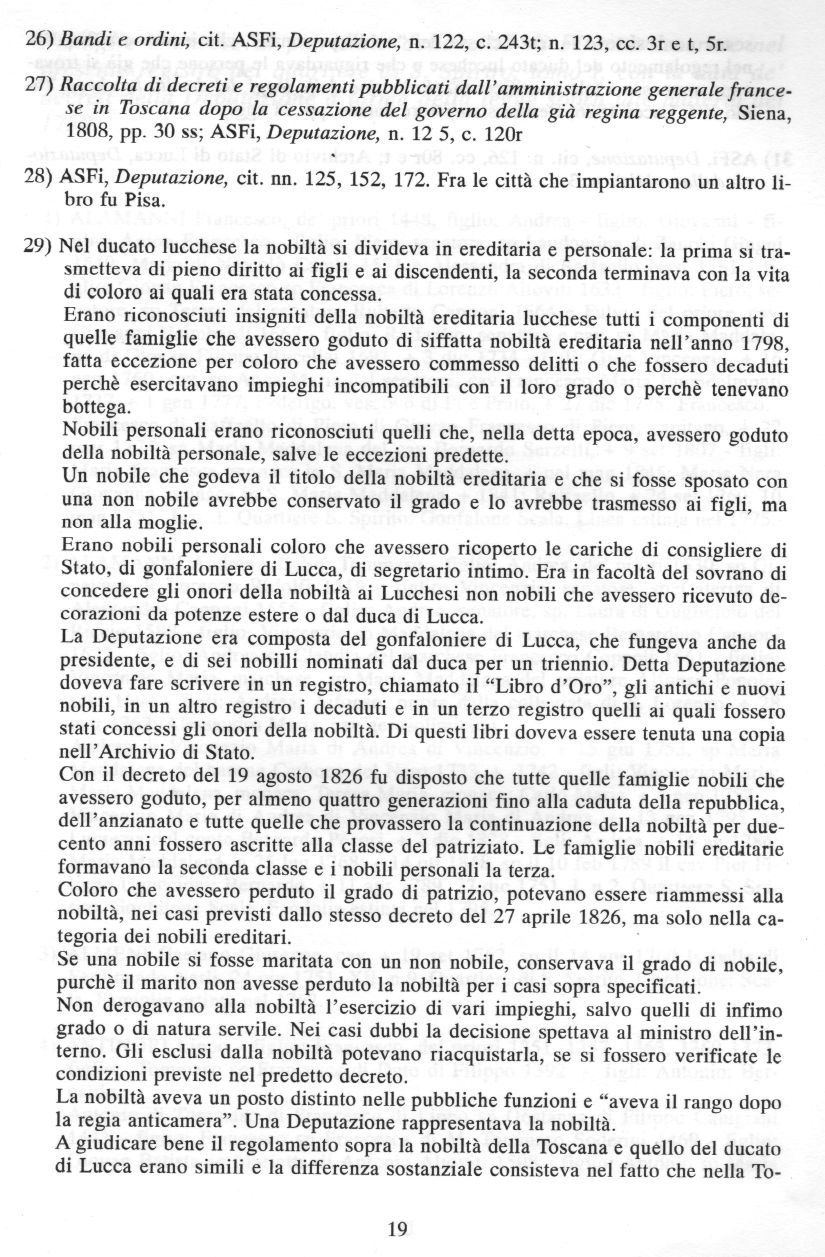
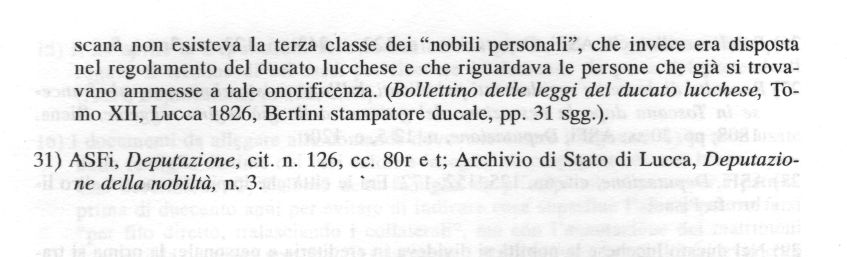
Questa legge rimase in vigore fino alla cessazione del Granducato di Toscana avvenuta nel 1859 e la successiva introduzione della Consulta Araldica del Regno di Italia e della legislazione nobiliare Sabauda
Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza (1750-1808)
ARCHIVIO DI STATO FIRENZE
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getsprod&id=IFDB744XXX&_language=eng&_selectbycompilationdate=&curwin=thirdwindow
ARCHIVIO DI STATO FIRENZE
http://www.archiviodistato.firenze.it/siasfi/cgi-bin/RSOLSearchSiasfi.pl?_op=getsprod&id=IFDB744XXX&_language=eng&_selectbycompilationdate=&curwin=thirdwindow
VEDI "I Libri d'oro della nobilta' fiorentina e fiesolana di Bruno Casini " ediz. Arnaud
Nelle prime sette "Citta' nobili "del Granducato di Toscana ( Firenze,Siena,Pisa,Pistoia,Arezzo,Volterra.Cortona e Montepulciano ) i nobili si distinguevano in due classi ,cioe' i nobili patrizi e i nobili semplicemente nobili . Della prima classe facevano parte tutte le famiglie nobili nelle quali erano state raccolte le provanze per giustizia all'ordine di santo Stefano e quelle famiglie nobili che potevano comprovare la propria nobilta' da duecento anni senza discontinuita' . Nella seconda classe dei nobili erano descritti i discendenti di quelle famiglie accolte nell'ordine di santo Stefano e le altre famiglie nobili che non potevano comprovare la loro nobilta' per il predetto periodo di tempo , ma per uno inferiore.
Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza
A partire dal 1750 nel Granducato di Toscana il riconoscimento della nobiltà e della cittadinanza divenne oggetto di una precisa procedura regolamentata dalla legge "per il regolamento della nobiltà e cittadinanza", promulgata a Vienna il 31 luglio e a Firenze il primo ottobre del 1750.
A tale procedura sovrintendeva la Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza che, proposta da Richecourt in un suo dispaccio al Granduca del febbraio 1749, fu effettivamente istituita nel contesto della legge del 1750. Pertanto, la documentazione conservata nel fondo rispecchia l'intero operato della Deputazione, il quale consisteva nell'esaminare le domande d'iscrizione, nel verificare le relative "provanze" e nel decidere di ammettere o meno al giudizio del Granduca - finale e insindacabile - le richieste presentate.
Così, un dossier standard conteneva la dichiarazione in cui il capo-famiglia esponeva il desiderio di far "descrivere" la propria casata ed enumerava i componenti in vita che sarebbero stati interessati all'operazione; il disegno delle armi della famiglia con la relativa descrizione araldica e l'indicazione dei luoghi in cui erano visibili; l'albero genealogico semplificato - in molti casi Giovan Battista Dei, Antiquario regio, ne era il redattore -, corredato di documentazione comprovante ricavata dall'archivio della Decima; estratti di battesimo o, in sostituzione, dichiarazioni d'età; dichiarazioni della dote. Nel corso di un tale procedimento si produceva e accumulava la documentazione che, nel sedimentarsi, ha prodotto l'archivio della Deputazione; esso testimonia un'attività che, salvo la breve interruzione del periodo francese (1808-1814), prosegue fino all'Unità d'Italia: per Firenze, ad esempio, le ultime iscrizioni nei registri sono relative al periodo 1847 per il patriziato (famiglia del principe Poniatowschi) e all'aprile 1860 per la nobiltà (fra le ultime iscrizioni di particolare interesse quella del conte Benso di Cavour).
La Deputazione fu istituita contestualmente alla pubblicazione della legge "per regolamento della nobiltà e cittadinanza" avvenuta a Vienna il 31 luglio e a Firenze il primo ottobre del 1750: ne fecero inizialmente parte Giovanni Antonio Tornaquinci, Consigliere di Stato e di Reggenza, nonché Segretario di Stato, Gaetano Antinori, Consigliere come il Tornaquinci e Segretario di Guerra, il senatore Giulio Rucellai, Segretario della Giurisdizione, e i senatori Filippo Guadagni e Giovan Francesco Ricasoli, che ebbero il compito di fare "pubblica descrizione delle [...] due classi, de' Patrizi, e dei Nobili colli dovuti esami, e riscontri delle domande, e recapiti ammissibili" secondo l'Istruzione pubblicata di seguito al testo della legge istitutiva. La Deputazione operava all'interno dell'Archivio di Palazzo - come allora era chiamato l'Archivio delle riformagioni -, nell'ambito della Segreteria di Stato, curando innanzitutto di allestire appositi registri "delle Classi de' Patrizi, e de' Nobili in buona, e valida forma distinti ed intitolati per ciascuna città da per se, ne' quali secondo l'ordine Alfabetico vi faranno dalli Ministri del detto Archivio registrare alla respettiva Classe tutte quelle Famiglie, che proveranno di avere li necessari requisiti per esservi ammesse". Tali requisiti - che tuttavia non dovevano essere posseduti contemporaneamente - erano: l'investitura di un feudo, l'ammissione a un ordine cavalleresco, il conferimento di un diploma del principe, l'esercizio di una suprema magistratura cittadina. Delle quattordici città del Granducato in cui si istituivano i registri della nobiltà, Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Arezzo, Volterra e Cortona erano classificate come "patrie nobili" - secondo criteri di antichità e celebrità da una parte e densità demografica dall'altra - e in esse l'aristocrazia era divisa in nobiltà semplice (famiglie con meno di duecento anni di titolarità dei requisiti nobiliari) e patriziato (famiglie con più di duecento anni di titolarità o appartenenti all'Ordine di Santo Stefano); nelle altre sette città - Sansepolcro, Montepulciano, Colle Val d'Elsa, San Miniato, Prato, Livorno e Pescia - veniva invece istituita la sola classe della nobiltà semplice (più tardi, e in momenti diversi, anche Pontremoli, Modigliana, Fiesole, Pietrasanta e Fivizzano ricevettero il rango di "città nobile").
La documentazione che i Deputati dovevano accogliere e vagliare per definire la posizione di quanti presentavano domanda per essere iscritti in una delle due suddette Classi, consisteva nell'albero genealogico di famiglia, comprovato da opportuni riscontri sui registri di decime, estimi, squittini, gabelle, contratti, battesimi e così via; nello stemma di famiglia, dipinto con i "suoi veri colori" e distinto con le sue proprie insegne; in eventuali diplomi di nobiltà, copie autentiche di rescritti e quant'altro concorresse a provare la nobiltà delle persone menzionate nell'albero genealogico; nelle fedi di decima, degli estimi e simili, o nelle copie "in valida forma" di testamenti, contratti d'acquisto e altra documentazione analoga; nelle attestazioni di cittadinanza. Circa i residenti fuori Firenze, la Deputazione si avvaleva della collaborazione dei giusdicenti di stanza nel territorio da cui proveniva l'aspirante alla carica di nobile o patrizio, i quali magistrati erano richiesti di fare "prontamente li dovuti riscontri de' Documenti annessi alle domande" per poi rimetterli, completata la documentazione eventualmente mancante e corredata di una propria relazione, di nuovo a Firenze all'Archivio di Palazzo perché la pratica potesse essere conclusa. Al termine del procedimento, le domande che risultavano idonee alla richiesta passavano all'approvazione del Granduca e, se accolte, venivano firmate dai membri della Deputazione e trasmesse, con tutta la documentazione del caso, agli incaricati dell'Archivio di Palazzo che a loro volta procedevano a copiare negli appositi registri gli stemmi e gli alberi delle famiglie riconosciute nobili o patrizie; le domande respinte, invece, dovevano essere dai Deputati corredate di una breve spiegazione relativa ai motivi che avevano portato all'esclusione della richiesta e potevano poi essere rimesse direttamente alla grazia del Granduca presentando una supplica al Consiglio di Reggenza. Comunque, tutte le domande, sia quelle accolte sia quelle respinte, venivano inviate dalla Deputazione all'Archivio di Palazzo dove si provvedeva a rilegarle in filze separate, ciascuna con i documenti annessi; il compito della Deputazione, poi, terminava con l'apposizione finale delle firme dei suoi membri sui registri originali del patriziato e della nobiltà.
La Deputazione, riunitasi a partire dall'ottobre 1750, nel mese di dicembre iniziò a esaminare i primi dossier di famiglie aspiranti all'iscrizione; le nobiltà del Granducato furono sottoposte a esame città per città: il lavoro venne portato a termine per Firenze e per Siena nel marzo del 1754, per Pisa in gran parte nel luglio dello stesso anno, per Pistoia nel luglio del 1755, periodo in cui si avviò l'esame della documentazione relativa ad Arezzo; nel 1784, infine, i lavori attinenti all'esame delle domande d'ammissione per tutto il Granducato si conclusero, dopodiché la Deputazione entrò nella fase per così dire di routine del proprio incarico consistente nell'aggiornamento progressivo dei registri di nobiltà già allestiti e vigenti. Con motuproprio del 29 ottobre 1792 (pubblicato il 30), poi, agli interessati che ancora non avevano provveduto si impose di presentare, entro due mesi dalla pubblicazione della legge, le "fedi autentiche" necessarie a essere iscritti nei "registri originali di patriziato e nobiltà", pena l'avvio di una procedura d'ufficio da parte della Deputazione, i cui oneri sarebbero totalmente ricaduti sugli inosservanti che inoltre avrebbero dovuto pagare una penale di tre lire per ogni fede rintracciata.
Nel 1793, con motuproprio del 12 giugno (pubblicato il 14), vennero finalmente dichiarati completati i registri di nobiltà e cittadinanza e l'Avvocato regio fu nominato "assessore" (ovvero, rappresentante legale) della Deputazione: il magistrato acquisiva in questo modo la facoltà di partecipare alle adunanze con diritto di voto e il compito di conservare personalmente i Libri d'oro della nobiltà e del patriziato. La Deputazione, in questo nuovo assetto e diminuita - almeno dal 1805 - di uno dei suoi cinque componenti originari, continuò a operare fino alla sua abolizione avvenuta con l'annessione del Granducato di Toscana all'impero francese
L'attuale ordinamento del fondo consente di individuare alcune serie omogenee di documentazione: una prima sezione comprende tutti i processi di nobiltà inoltrati alla Deputazione dal 1750 al 1860, insieme a tutta la documentazione probatoria richiesta dalla legge; la medesima organizzazione degli atti si riscontra nella serie relativa ai processi di cittadinanza. Inoltre, poiché i candidati che non erano stati ammessi al rango richiesto potevano presentare una supplica direttamente al Granduca, è stata individuata la serie distinta delle Suppliche, dotata di un proprio indice. Analogamente, parte della documentazione presentata dai capi-famiglia per l'iscrizione al rango nobile costituisce serie a sé stanti: si tratta, in particolare, di fedi di nascita, morte e matrimoni, dei diplomi di nobiltà e delle armi gentilizie. Gli stemmi e gli alberi genealogici delle famiglie iscritte alla nobiltà, ordinati alfabeticamente, formano ancora una serie separata, denominata Libri d'oro. Alcuni registri, poi, conservano la corrispondenza prodotta e ricevuta dalla Deputazione e hanno dato vita a tre serie autonome: i copialettere, le lettere in arrivo, il carteggio con i giusdicenti e con i cancellieri comunitativi.
Famiglie iscritte nei libri d'oro della nobilta' di Firenze
|
Acciaiuoli |
Bacci |
Caccini |
Dainelli da Bagnano |
|
Adimari |
De Baciocchi |
Cadorna |
Dandi dei conti di Gangalandi |
|
Alamanni |
Danielli da Bagnano |
Caimi |
Danielli da Bagnano |
|
Albergotti |
Bagnesi |
Calderini |
Dati |
|
Alberti |
Baillou |
Cambi |
Davanzati |
|
Albertini |
Baldesi |
Cambini |
Dei |
|
Albizzi |
Baldi |
De Cambray Digny |
De Demidoff |
|
Aldana |
Baldigiani |
Campi da Torricchio |
Dewit |
|
Aldobrandini |
Baldini |
Canacci |
Dini |
|
Alessandri |
Baldinotti |
Canigiani |
Dithmar di schmidueiller |
|
Alli |
Baldocci |
Canigiani de Cerchi |
Doni |
|
Almeni |
Baldovinetti |
Cantucci |
Donnini |
|
Altoviti |
Baldovinetti di Poggio |
Cappelli |
Dufour |
|
Altuiti-Ugolini |
Bambagini |
Capponi |
Dufour berte |
|
D'Ambra |
Da Barberino |
Carcherelli |
Durazzini |
|
Ambrogi |
Barbolani |
Cardi |
Ercolani Onesti |
|
Dall'Ancisa |
Bardelli |
Cardicigoli |
Eynardlullin |
|
Anforti |
Bardi |
Carducci |
Fabbreschi |
|
Anichini |
Barducci Cherichini |
Carlini |
Fabbri |
|
Ansaldi |
Bargigli |
Carnesecchi |
Fabbrini |
|
Anziani |
Baroncini |
Carrara |
Fabrini |
|
Antinori |
Bartoli |
Casini |
Fabrini dagli aranci |
|
Ardimanni |
Bartoli Filippi |
Castellani |
Falagiani |
|
Arnaldi |
Bartolini |
Castelli |
Falconieri |
|
Arrighetti |
Bartolini Baldelli |
Da Castiglione |
Falcucci |
|
Arrighi |
Bartolini Salimbeni |
Cataldi |
Fantoni |
|
Degl'Asini |
Bartolommei |
Cattani |
Federighi |
|
Attavanti |
Basili Bartolini |
Cavalloni |
Fedini |
|
Avila |
Beccanugi Ammannati |
Cecchini |
Fenzi |
|
D' Azzi |
Beccuto |
Cellesi |
Feroni |
|
|
Bechi |
Da cepperello |
De Ferra |
|
|
Belfredelli |
Ceramelli |
Ferrucci |
|
|
Belli |
Cerbini Bonaccorsi |
Fiaschi |
|
|
Bellini |
De Cerchi |
Figlinesi |
|
|
Bellini delle stelle |
Cerretani |
Da Filicaia |
|
|
Belriguardo |
Cerretesi |
Firidolfi |
|
|
Bencivenni |
Chellini |
Foggi borghi |
|
|
Del Benino |
Ciacchi |
Fontebuoni |
|
|
Benso di Cavour |
Cicciaporci |
Formigli |
|
|
Benvenuti |
Cignani |
Forti |
|
|
Berardi |
Cinotti |
Da fortuna |
|
|
Beroardi Dragomanni |
Cioni |
Franceschi |
|
|
Berti gia Da Vicano |
Cipriani |
Francesconi |
|
|
Bertini |
Cocchi |
Franchini |
|
|
Betti |
Coletti |
Franchini |
|
|
Bianchi |
Collarini |
Francois |
|
|
Biffi |
Collini |
Franzesi |
|
|
Biliotti |
Colson |
Frescobaldi |
|
|
Bini |
Compagni |
Fulger |
|
|
Biondi |
Comparini |
|
|
|
Bittheuser |
Coppi |
|
|
|
Bocchineri |
Coppoli |
|
|
|
Bologna |
Corboli |
|
|
|
Bolognini |
Corsetti |
|
|
|
Bonaparte |
Corsi |
|
|
|
Buonaparte |
Corsi Puccini |
|
|
|
Bonecchi |
Corsini |
|
|
|
Bonfini |
Cosi |
|
|
|
Bonsi |
Covoni Girolami bettoni |
|
|
|
Della Bordella |
Covoni |
|
|
|
Borgherini |
|
|
|
|
Borghese |
|
|
|
|
Borghini |
|
|
|
|
Dal borgo |
|
|
|
|
Boverelli |
|
|
|
|
Bourbon del monte |
|
|
|
|
Bracci |
|
|
|
|
Branchi |
|
|
|
|
Brandolini |
|
|
|
|
Brichieri |
|
|
|
|
Brizzi |
|
|
|
|
Broccardi Schelmi |
|
|
|
|
Brocchi |
|
|
|
|
Brunaccini |
|
|
|
|
Buini |
|
|
|
|
Buonaccorsi |
|
|
|
|
Buonaccorsi Dolcini |
|
|
|
|
Buonaini |
|
|
|
|
Buonamici |
|
|
|
|
Buonarroti |
|
|
|
|
Buondelmonti |
|
|
|
|
Del buono |
|
|
|
|
Buontalenti |
|
|
|
|
Busacca |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gabrielli |
Havet |
Macciagnini |
|
Gabburri |
Hayre' |
Macigni |
|
Gabellotti |
D'Humbourg |
Del maestro |
|
Gaddi |
Humburgo |
Maggio |
|
Gaetani |
Incontri |
Maglioni |
|
Galeffi Cappelletti |
Inghirami |
Magnani gerbi |
|
Galeotti |
Kaiser |
Malaspina |
|
Galganetti |
Landi |
Malevolti |
|
Galilei |
Lami |
Mancini |
|
Galletti |
Lanfranchi Rossi |
Manetti |
|
Galli |
Lanfredini |
Mannelli |
|
Gallitassi |
Lapi |
Mannini |
|
Ganucci |
Lapi ne Matteoni |
Mannucci |
|
Del Garbo |
Laugier |
Marchi |
|
Gargiolli |
Lenzoni |
Marchionni |
|
Garzoni Venturi |
Leonetti |
Mari |
|
Gatteschi |
Libri |
Marmi |
|
Gauard des pivets |
Lippi |
Marsili |
|
Gaulard |
Lippi Uguccioni |
Martelli |
|
Geppi |
Lorenzi |
Martellini |
|
Gerini |
Lorenzini |
Martin |
|
Gervais |
Lotteringhi della stufa |
Martini |
|
Gherardesca |
Lottinger |
Maruccelli |
|
Gherardi |
Luccattini |
Marulli |
|
Gherardini |
Luci |
Marzichi |
|
Giacomelli |
Luciani passeri |
Marzimedici |
|
Giacomini Tebalducci |
Luperelli |
Masetti |
|
Gianfigliazzi |
Lupi |
Masetti Dainelli da Bagnano |
|
Giannetti |
Lustrini |
Mattei della scala |
|
Gianni |
|
Matteoni da Sommaia |
|
Gilioli |
|
Del mazza |
|
Gilkens |
|
Mazzei |
|
Gilles |
|
Mazzinghi |
|
Ginori |
|
Medici |
|
Ginori Lisci |
|
De medici |
|
Giorgi |
|
Medici di Zara |
|
Giovacchini da Firenzuola |
|
Menchi |
|
Giovagnoli |
|
Mercati |
|
Giovagnoli Nomis |
|
Michelozzi |
|
Giraldi |
|
Migliorati |
|
Girolami |
|
Migliorucci |
|
Giugni |
|
Milanesi |
|
De Giunti Modesti |
|
Miliotti |
|
Giuntinelli (oggi D'Ambra ) |
|
Minerbetti |
|
Giuntini |
|
Mini |
|
Giusti |
|
Miniati |
|
Goggi |
|
Moneta |
|
Gondi |
|
Montalvi |
|
Gori |
|
Morali |
|
Grazzini |
|
Morelli |
|
Griccioli |
|
Moresi |
|
Grifi |
|
Moretti |
|
Grifoni |
|
Mori Ubaldini |
|
Grobert |
|
Mori Ubaldini alberti |
|
Grottanelli |
|
Mormorai |
|
Guadagni |
|
Morrocchi |
|
Guasconi |
|
Mozzi |
|
Guasconi di Palermo |
|
Mutti |
|
Guasconti |
|
Muzzi |
|
Guazzesi |
|
|
|
La Guerre |
|
|
|
Guerrini |
|
|
|
Guicciardini |
|
|
|
Guidetti |
|
|
|
Guidi |
|
|
|
Guiducci |
|
|
|
Naldini |
Paganelli |
Quaglia |
Sabatini |
|
Narvaez e Saavedra |
Pagnini |
Quaratesi |
Sacchettini |
|
Nasi |
Palmieri della camera |
Da Rabatta |
De Saint Seigne |
|
Nati Poltri |
Palmieri |
Ranalli |
Salvagnoli |
|
Della nave |
Panciatichi |
Della rena |
Salvatici |
|
Nelli |
Pandolfini |
Restoni |
Salvetti |
|
Del nente |
Panzanini |
Ricasoli |
Salviati |
|
Nerettoi |
Paolini |
Ricasoli baroni |
Salvini |
|
Neri |
Papi |
Riccardi |
Sangalletti |
|
Neri badia |
Parenti |
Ricci |
Sanminiati |
|
Neri ridolfi |
Parlatore |
De ricci |
Sarchi |
|
Nerli |
Pasquali |
Ricciardi |
Sassatelli |
|
Del Nero |
Pasqui |
Riccio Baldi |
Sassi |
|
Neroni |
Passerini |
Ridolfi |
Sassi della Tosa |
|
Nervi |
Paur de Ankerfeld |
Rigogli |
Sauboin |
|
Niccolai |
Paver |
Rilli |
Scalandroni |
|
Niccolini Sirigatti |
Pavini |
Rimbotti |
Scalini |
|
De nobili |
Pazzi |
Rimediotti |
Scaramucci |
|
Novellucci |
Pecori |
Rinaldeschi |
Scarlatti |
|
Nozzolini |
Pellegrini |
Rinaldi |
Schianteschi |
|
Nucci |
Pelli |
Rinuccini |
Del sera |
|
Obizzi |
Pepi |
Ristori |
Seratti |
|
Orlandi |
Perini |
Roffia |
Serguidi |
|
Orlandini |
Petrowitz |
Ronchivecchi |
Sermolli |
|
Orsi |
Peruzzi |
Rondinelli |
Serrati |
|
Orsini |
Piacenti |
Rosselli |
Serristori |
|
|
Pierucci |
Rosselmini |
Serzelli |
|
|
Pirri |
Rossi |
Sesti |
|
|
Pitti |
Rossi da Piantravigna |
Setticelli |
|
|
Poggi |
Del Rosso |
Settimanni |
|
|
De Poirot |
Del Rosso vaiai |
Siminetti |
|
|
Poirot de la blandinier |
Roti |
Soderini |
|
|
Poltri |
Rucellai |
Soldani Benzi |
|
|
Poniatowski |
Del ruota |
Spina |
|
|
Pontanari |
|
Spinelli |
|
|
Pontini |
|
Spini |
|
|
Popoleschi |
|
Squarcialupi |
|
|
Portigiani |
|
Stefanopoli |
|
|
Dalle pozze |
|
Stendardi |
|
|
Pratellesi |
|
Stiozzi |
|
|
Pucci |
|
Strozzi |
|
|
Pucci da Filicaia |
|
Suares de la Conca |
|
|
Puccini |
|
Subbiani |
|
|
Del pugliese |
|
Suterman |
|
Taddei |
Ubaldini |
Ward |
|
|
Talenti |
Ughi |
Ximenes |
|
|
Tamburini |
Ugolini |
Zati |
|
|
Tassinari |
Ulivelli ulivieri |
Zeti |
|
|
Tavanti |
Ulivi |
|
|
|
Tedaldi |
Urbani |
|
|
|
Tempi |
Vaglienti |
|
|
|
Teri |
Vai |
|
|
|
Terrosi |
De la Valette |
|
|
|
Testard |
Valleron d'Orqueuaux |
|
|
|
Tolomei |
Vannucchi |
|
|
|
Tolomei baldovinetti di Poggio |
Vannucci |
|
|
|
Toriglioni |
Vavassori |
|
|
|
Tornaquinci |
Vecchi |
|
|
|
Torrigiani |
Vecchietti |
|
|
|
Torsellini |
Velluti |
|
|
|
Tosi |
Venturi |
|
|
|
De la Tour en voivre |
Verdi |
|
|
|
Del turco |
Vernacci |
|
|
|
Del Turco Dazzi |
Del Vernaccia |
|
|
|
|
Da verrazzano |
|
|
|
|
Vespucci |
|
|
|
|
Vettori |
|
|
|
|
Vitolini |
|
|
|
|
Del Vivaio (oggi Vivai ) |
|
|
|
|
Viviani |
|
|
LA RINASCITA DEL GRANDUCATO COI LORENA ED UNA NUOVA E DIVERSA DIMENSIONE DEI CARNESECCHI
Alcune delle famiglie Carnesecchi che erano riuscite a restare agganciate al treno aristocratico di Firenze non possedevano piu' i requisiti patrimoniali per essere ammessi nelle liste della nobilta' altre forse non erano interessate perche' ormai molto fuori da quel mondo
Si era spezzato come un antico incanto e tutti i Carnesecchi erano poveri e sembrano svuotati di energie
|
dal libro : Le tre Nobiltà, di Marcella Aglietti a cura dell'Istituzione dei cavalieri di S.Stefano, ed. ETS Pisa:
|
|
Scegli la pagina …………………VAI ALL'INDICE GENERALE |
RESTARE NOBILI PERDENDO LA NOBILTA'
https://books.openedition.org/efr/9268
Il caso del Granducato di Toscana tra Sette e Ottocento
Marcella Aglietti
Il saggio prende in esame gli effetti della legge per regolamento della nobiltà nel granducato di Toscana, introdotta nel 1750, sulle dinamiche di decadenza dalla condizione nobiliare. L’esame della documentazione prodotta nel corso di un secolo al fine di consentire, o respingere, l’iscrizione al ceto, rivela che il temuto declassamento, inteso come la perdita della nobiltà conseguente a un mancato riconoscimento, interessò una esigua minoranza di casi. L’atteggiamento prevalente da parte delle autorità granducali fu piuttosto di concedere deroghe e sanatorie al fine di consentire a quanti fossero privi di sufficienti giustificazioni di provvedere con integrazioni, modifiche o, nella peggiore delle ipotesi, ricorrendo alla grazia derogatoria del granduca.
1I ceti nobiliari del Granducato di Toscana, come ben mette in luce una copiosa storiografia, seppero dar prova di grande longevità preservando buona parte della propria identità originaria. Le strategie messe in atto durante il dominio della dinastia medicea, poi di quella lorenese, e ancora durante il Risorgimento ottocentesco, consentirono alle più antiche élite toscane di mantenersi saldamente al loro posto persino nel nuovo ordinamento statuale introdotto con l’unificazione1. A un esame più attento, la documentazione rivela che il prezzo da pagare fu però il progressivo logoramento e avvilimento della condizione nobiliare. Al di là delle permanenze, tra il 1750 e il 1859, sostanza e rappresentazione della nobiltà granducale cambiarono e ciò anche a seguito dell’introduzione di una norma che, voluta per espungere dal ceto gli elementi indegni, ne favorì al contrario l’indebolimento, portando alla sua dequalificazione.
2La legge «per regolamento della nobiltà e la cittadinanza» promulgata da Francesco Stefano di Lorena il 31 luglio 1750 fu la prima in materia valida su tutto il territorio granducale2. Com’è noto, il granduca, assurto al trono fiorentino da poco più di un decennio, volle così assicurarsi il controllo sulle dinamiche di cooptazione e di nobilitazione, superando il particolarismo che aveva rappresentato da sempre un tratto distintivo delle oligarchie cittadine toscane. Tutti coloro che, persuasi del proprio diritto ad appartenere al ceto aristocratico, vollero veder riconosciuta la propria condizione, furono obbligati a dimostrarlo. Una apposita commissione – la deputazione sopra il regolamento della nobiltà e la cittadinanza3 – ebbe il compito di passare al vaglio titoli e provanze per l’ascrizione, o meno, nel «libro d’oro» della città di residenza4. Di fatto, si trattò del primo censimento esaustivo della nobiltà toscana.
3Il fondo che raccoglie l’insieme dei fascicoli contenenti sia le prove addotte dai richiedenti, sia il lavoro istruttorio dei deputati, offre un laboratorio ideale per verificare forme di declassamento o altri effetti della legge sulla composizione dell’élite nobiliare, sulla sua identità e rappresentazione. In particolare, sono apparsi di estremo interesse i rapporti della sezione degli Affari sospesi, relativi ai nobili considerati dubbi e in merito ai quali si richiesero deliberazioni granducali, supplementi d’istruttoria o pareri interpretativi della legge5.
4Il disposto normativo dedicava alcuni articoli alla perdita della nobiltà, ma i deputati, dopo un iniziale tentativo di applicazione rigorosa e restrittiva, constatata l’assenza di strumenti sanzionatori adeguati, optarono in via di prassi per una linea assai più conciliante. Così, ad esempio, a fronte della esecrata diffusione dei «matrimoni ineguali» e dell’esercizio di professioni «vili» e, quindi, incompatibili, apparve più utile escogitare soluzioni volte a sanare e a derogare. Laddove ci si aspetterebbe un intervento regolatore all’insegna della selezione e della esclusione, con provvedimenti volti ad espungere soggetti o casati per vizi di forma o di sostanza, compaiono piuttosto delibere «sospensive». Del resto, la volontà compromissoria nei confronti delle gerarchie locali appare evidente fin dall’inizio: prima di valutare le domande degli aspiranti nobili, i deputati interpellavano le autorità municipali per avere una «esatta relazione» per «bene intendere la costituzione civile» di ogni città6. Un’indagine che veniva condotta anche in caso di nuove aggregazioni per grazia sovrana, così da verificare in loco le qualità del supplicante o, meglio, che vi fosse consenso attorno a quella promozione senza «pregiudicare al buon ordine»7.
5In linea generale, le lacune evidenziate dai deputati nei curricula dei nobili toscani venivano sanate integrando con giustificazioni e certificati genealogici, titoli di merito o forme di sostentamento aggiuntive, o interrompendo l’esercizio di «mestieri vilissimi» che erano stati all’origine della sospensione8. Qualora non fosse possibile sopperire in via documentaria, restava sempre il ricorso alla grazia sovrana.
6Questo atteggiamento conciliante della deputazione, amplificato da ulteriori misure mitigatrici introdotte successivamente, contribuì ad accelerare un processo di svilimento del credito sociale della condizione nobiliare, inficiando altresì una compiuta affermazione dell’autorità sovrana sui meccanismi di riproduzione oligarchica. Attività lecite ed illecite: un declassamento «sotto condizione»
7La legge per regolamento della nobiltà contemplava due cause principali di decadenza: l’esser riconosciuti colpevoli di un delitto e l'esercizio di arti vili e meccaniche.
8Quanto al primo motivo, il disposto sanciva la perdita di status per il nobile condannato insieme ai discendenti nati successivamente al reato, ma non per il resto della famiglia (a meno che non si trattasse di delitto di lesa maestà). Così la norma, ma nei documenti prodotti per l’ammissione, quel buon numero di soggetti perseguiti e condannati tra i ranghi della turbolenta aristocrazia toscana quasi non lascia traccia di sé, evidentemente per esser stati già espunti dagli alberi genealogici quali componenti indesiderati. Negli oltre mille fascicoli compilati nei primi sessant’anni di lavori, solo sei menzionano individui colpiti da pena capitale o confino, mentre le richieste di supplemento d’istruttoria da parte dei deputati a fronte di alberi genealogici lacunosi restano spesso l’unica traccia della presenza di un condannato9.
9Seppur non prescritti dalla legge, i deputati considerarono però meritevoli di decadenza o sospensione dalla nobiltà anche altri comportamenti. Tra questi vi fu l’addurre documenti falsi, soprattutto genealogie e attestati artefatti, evenienza molto frequente, spesso anche reiterata da una stessa famiglia a distanza di anni. La deputazione vi ravvisò motivo sufficiente per negare l’aggregazione al rango e, almeno in un caso, propose al granduca l’emanazione di un decreto negativo che esplicitasse l’assenza di nobiltà del soggetto in questione per impedirgli ulteriori tentativi in futuro10. Altro atto giudicato punibile con la sospensione dal godimento della nobiltà fu il non onorare la parola data, soprattutto se riguardava un vincolo matrimoniale11.
10In merito all'esercizio di arti o professioni, la legge ordinava la decadenza ipso facto dell’interessato e dei discendenti nati successivamente, salvo l’intervento sanatorio di un diploma di grazia granducale. Il disposto modulava un precetto già vigente in diritto comune12, ma a fronte del divieto di esercitare i mestieri di speziale, chirurgo, procuratore, notaio, attuario, cancelliere, nonché di qualunque altra attività meccanica o manuale, e della mercatura (se non nel caso in cui fosse stata magna e copiosa), la discrepanza tra il dettato normativo e alcune consuetudini locali apparve subito problematica. In particolare, le professioni di cancelliere e di notaio erano state considerate, fin dai tempi della Repubblica, non solo compatibili con la nobiltà, ma addirittura una prerogativa nobiliare13. Nella consapevolezza della difficoltà attuativa della prescrizione, né potendo reclamare per la legge efficacia retroattiva, si consentì comunque la registrazione ai libri d’oro a condizione dell’interruzione dell’impiego attastata anche tramite appositi certificati pubblici. In caso di mancato adempimento sarebbe avvenuta d’ufficio la cancellazione, eppure non furono pochi coloro che, pur dichiarata la cessazione, proseguirono segretamente le proprie attività. Del resto, i primi a ricorrere a questo tipo di registrazione sotto condizione furono alcuni «nati da nobili famiglie che esercitavano la carica di cancelliere per sostenere con gli stipendi di tal esercizio il decoro delle loro Case». Costoro evidenziarono l’impossibile scelta tra due forme di declassamento: una in via di fatto, lasciando l’impiego in cambio dell’ascrizione, ma condannando se stessi e i propri familiari alla miseria; l’altra in via di diritto, rinunciando al proprio nome nei libri d’oro, ma assicurando un reddito necessario per vivere more nobilium e conservare le insegne del prestigio sociale14. La soluzione prospettata dai deputati, in questo come in altri casi analoghi, fu quasi sempre quella del giusto mezzo: furono concesse proroghe, anche rinnovate più volte o addirittura senza una data di termine, consentendo l’iscrizione al registro e la contemporanea prosecuzione dell’attività.
11Lo spoglio dei fascicoli evidenzia ulteriori professioni che, pur non menzionate come incompatibili dalla legge, lo furono dalla deputazione in via d’analogia. Tra queste, si trova anche l’attività consolare, riconosciuta inadatta al rango nobiliare in considerazione dell’elevato numero di soggetti che la esercitavano a Livorno e che avrebbe inflazionato il prestigio di ceto15. Declassamento o degrado? La nobiltà povera
12La questione emersa rispetto alla necessità per alcuni di proseguire attività redditizie per il proprio sostentamento fu solo una delle conferme del crescente immiserimento della nobiltà toscana. Il fenomeno era noto da tempo, ma durante la seconda metà del Settecento colpì con intensità le maggiori città: Firenze, Siena, Pisa, Pistoia e Arezzo.
13Il giureconsulto aretino Francesco de’ Rossi, auditore ed erudito, nel 1764 dedicò un capitolo delle sue Considerazioni morali, economiche e politiche al nobile povero, indicandolo quale «il più dannoso cittadino che viva nella società». Lo ritenne ben più nocivo degli altri poveri in quanto la sua «cattiva educazione, o la mala inclinazione», gli impediva di dedicarsi a qualche «onesta occupazione» per risanare la propria condizione, condannandolo a una vita oziosa, avvelenata dall’invidia. Oltre agli effetti della condanna morale, la mancanza di mezzi avrebbe esposto simili individui a un tale disagio esistenziale da trasformarli in un veleno per l’intera società, la loro sorda malevolenza avrebbe ostacolato ogni progresso scientifico e artistico, intralciando il trionfo del merito. Inoltre, angustiati dal rischio di esser declassati al ceto immediatamente inferiore, costoro fomentavano un odio feroce nei confronti dei cittadini, soprattutto se benestanti. I nobili declassati, convinti di essere i soli a poter «star bene», non colpivano i loro pari ma «quelli che sono dell’ordine di mezzo, dei cittadini, i quali vorrebbero ad ogni costo veder poveri e indebitati»16. Insomma, il sentimento d’appartenenza superava anche il livore della decadenza: intollerabile non poter sfoggiare maggior agiatezza di un cittadino qualsiasi, la separatezza tra i due ordini doveva restare inviolato.
14Per la deputazione, la «scarsità delle entrate» costituiva causa ostativa non solo per il conferimento ex novo della nobiltà, ma anche per l’aggregazione di casati di antico lignaggio, se troppo impoveriti. Diversamente si sarebbero prodotti «due mali: quello cioè di nuocere all’industria commerciale, che per il solito si abbandona dai nobili; e l’altro del poco decoro del ceto, quando le forze patrimoniali non giungano a quel distinto ed onorato trattamento tante volte rammentato nella legge del 1750»17. Ciò nonostante, ancora una volta, la pur così di sovente lamentata «scarsità degli assegnamenti e le limitate finanze» non divennero quasi mai motivo di declassamento, né ragione di mancata nobilitazione sovrana. In uno dei rari casi in cui si respinse la grazia di nobiltà a un soggetto risultato poco abbiente, i deputati ne attribuirono la decisione non alla tutela del decoro cetuale, ma al fatto che la nobilitazione avrebbe arrecato più danni che vantaggi al supplicante che si sarebbe trovato costretto, da un lato, a maggiori spese per garantirsi la «debita decenza» e, dall’altro, a perdere quei sussidi caritatevoli cui aveva diritto solo restando nel ceto cittadino e invece tanto necessari per «collocare» le figlie nubili18. Del resto, si osservava, il numero dei nobili bisognosi era in continuo aumento, occorreva quindi evitare di aggiungerne di nuovi o i fondi destinati al loro sostentamento da non pochi lasciti testamentari a ciò imputati non sarebbero stati più sufficienti.
15I deputati denunciarono ripetutamente la mancanza di strumenti validi per accertare il possesso di redditi adeguati. A quanti ricorrevano alla grazia sovrana, e ai moltissimi che addussero a sostegno del proprio status uno o più cavalieriati per giustizia dell’Ordine di Santo Stefano, la legge non chiedeva alcuna prova patrimoniale. Il manto rossocrociato, in particolare, era titolo idoneo per l’aggregazione alla nobiltà, e persino al patriziato. Nondimeno, segni di mobilità sociale discendente tra gli stefaniani erano ormai inequivocabili. Dal 1751 il granduca introdusse una sorta di stipendio mensile per i cavalieri impegnati nella navigazione, per quelli anziani e persino, in misura più ridotta, per i giovani apprendisti durante il periodo di addestramento; mentre dal 1753, un motuproprio fissò un minimo di 300 scudi d’entrata annua per gli aspiranti l’abito cavalleresco19. Poco più che palliativi, anche a causa del progressivo impoverimento del patrimonio fondiario dell’Ordine, dalle cui rendite dipendeva il sostentamento di tanta nobiltà toscana. Qualche decennio più tardi, l’Ordine avrebbe dovuto disporre l’esecuzione a proprie spese persino delle cerimonie funebri di molti cavalieri deceduti in stato di povertà20.
16D’altro canto, era difficile stabilire un reddito minimo esigibile perché era legato alla percezione pubblica, soggetta a variazioni anche significative tra la capitale e le altre città periferiche del granducato. Solo per effetto della riforma comunitativa del 1780 e della legge del 1784 che riconobbero alle Comunità il diritto di proporre nuove aggregazioni, l’importanza riconosciuta alla proprietà e al successo negli affari segnò il passaggio a una mobilità sociale più sensibile ai criteri plutocratico-patrimoniali21. Nel 1795, i deputati sottoposero al granduca la proposta di richiedere almeno il possesso di un «censo patrimoniale» minimo, oltre ai requisiti di civiltà dei natali e delle nobili parentele. L’entità del censo andava calcolato in base al costo della vita, anzi del «nobile trattamento», nelle diverse città, ipotizzando ad esempio un’annua rendita di scudi 3000 per Firenze, scudi 2000 per le città patrizie e 1500 scudi per le altre località dotate della sola nobiltà semplice22. Si auspicava così di sanare quella «debolezza quasi comune» di chi ambiva alla nobiltà senza avere «sufficienti ricchezze per mantenerne il conveniente lustro», un combinato che stava moltiplicando «all’infinito» le domande di ascrizione di soggetti privi di mezzi. La proposta del censo minimo non ottenne però l’appoggio governativo, e fu bocciata dal consigliere di Stato Ernesto di Gilkens.
17Con toni crescenti dalla seconda decade dell’Ottocento, i deputati accusarono le magistrature cittadine, ormai autorizzate a proporre candidati per impinguare i libri d’oro, di non muovere nell’interesse del «lustro del ceto nobile», bensì «sedotte dall’interesse» per le somme cospicue dovute alle casse pubbliche dai nuovi ammessi23. Tanto più che, per evitare conflitti coi propri concittadini, le Comunità assecondavano le ambizioni degli aspiranti nobili senza condurre alcuna istruttoria, rendendo impossibile per i deputati opporsi a quelle promozioni anche qualora si fosse trattato di «famiglie prive di assegnamenti, necessitate per vivere a ricorrere ai sussidi caritativi e dei particolari e dei luoghi pii». Un fenomeno, quest’ultimo, in continua crescita, e ben noto alla deputazione, chiamata in causa anche nel rilascio dei certificati necessari a godere di tali beneficenze. Gli inconvenienti dell’ammissione di famiglie «scarse di beni di fortuna» furono ben presto evidenti: in molte andarono incontro alla «rovina», generando tra i nobili più facoltosi «una schiera di lamenti» e lasciando «degradato […] lo splendore dell’ordine, con lesione di quella massima che lo assiste in ogni ben regolato governo». Nobiltà femminili: tra declassamento e opportunità
18Nei fascicoli sottoposti all’esame della Deputazione, la condizione femminile non risultò meritevole della stessa attenzione di quella maschile. Un aspetto in contraddizione con quanto previsto dalle norme di accesso all’Ordine di Santo Stefano, nelle quali si esigeva invece la prova della nobiltà femminile per i quattro quarti del pretendente l’abito per giustizia24 e, dal 1786, esclusero i successori nati da madre non nobile25. Furono in molti, sia fra i nobili, sia fra i funzionari locali addetti alla collazione dei documenti da inviare a Firenze, che ritennero la nobiltà femminile «prova puramente facoltativa e non necessaria». I deputati in più occasioni richiesero supplementi d’istruttoria quanto ai «parentadi delle femmine entrate» in famiglia, minacciando gravi multe in caso d’inadempienza e persino il respingimento della richiesta26.
19A un esame più attento, anche i deputati intesero la nobiltà femminile più come una qualità morale che una condizione giuridica o sociale individuale, e comunque sempre vincolata in modo inscindibile allo status del padre prima, del marito poi, del fratello o del figlio in ultima istanza. Insomma, una qualità effimera, transeunte, e perdurante solo durante l’esistenza di quel legame legittimo di parentela27. Persino in caso di nobilitazione per grazia sovrana, la donna riceveva di riflesso tale status «rimanendo da per sé stessa nobilitata implicitamente col diploma paterno», ma con effetti così limitati da perderlo in caso di matrimonio e da non goderne affatto se, ad esempio, il beneficiario fosse stato il fratello, a meno che non apparisse espressamente menzionata nel diploma granducale28.
20Quanto al declassamento vero e proprio, la legge del 1750, all’art. 31, ne contemplava l’eventualità nel solo caso in cui la nobildonna avesse contratto matrimonio con un uomo di ceto inferiore. In base alla norma, un matrimonio ineguale non causava la cancellazione dai registri nobiliari né della donna, né del suo casato, salvo renderla inabile a godere dei privilegi del rango ricadendo, insieme alla propria progenie, nella condizione sociale del marito.
21Come per i rei, la documentazione condannava all’oblio le donne colpevoli di «unione vile» cancellando ogni traccia della loro esistenza. Lo si evince dalle rare, improvvise riapparizioni di figlie e sorelle negli aggiornamenti inviati alla deputazione in epoche successive qualora la donna avesse sanato, magari con la vedovanza o un secondo matrimonio, la ragione della sua previa decadenza29.
22La legge nulla diceva rispetto alle conseguenze di un matrimonio diseguale ove fosse stata la donna ad essere di condizione inferiore. Del resto, il coniugio con una ragazza non nobile, ma dotata di un importante patrimonio, poteva dare accesso a mezzi economici utili all’intero casato. Anche la Deputazione, in via di prassi, non vi ravvisò motivo di stigmatizzazione sociale: era anzi un segno di declino facilmente sanabile se la moglie acquisiva lo status del marito, mettendo a salvo il buon nome dei discendenti. Furono molti i mariti che implorarono la registrazione di consorti di «condizione civile», ottenendo per lo più l’accoglimento alla luce del «savio intendimento di rendere pari di faccia alla famiglia la condizione di ambedue i coniugi»30. La nobiltà così acquisita dalla donna, non de jure ma de facto, restava personale e cessava al momento del decesso del consorte. Nel caso, ad esempio, del diritto di accesso ai Casini nobiliari, i deputati proposero l’accoglienza solo di donne che, «oltre ad essere maritate a persone nobili, avessero ancora la nobiltà della loro propria famiglia». Rescritto granducale ratificò quanto formulato il 10 marzo 1774, aggiungendo però un «ferme stanti l’ammissioni già fatte», principio poi esteso a tutti i Casini delle altre città toscane con l’ordine del 31 gennaio 179131. Declassamenti parziali: da patrizi a nobili semplici
23La legge del 1750 distingueva i nobili in due categorie: il patriziato per quanti fossero in grado di dimostrare 200 anni ininterrotti di antichità del titolo, e la nobiltà semplice per i casati di più recente aggregazione. La registrazione avveniva presso la «città nobile» nella quale risiedeva il comparente, un aspetto che non mancò di originare qualche problema.
24La legge infatti riconosceva il patriziato solo in sette città del granducato, quelle più popolose e di antica tradizione civile, mentre in altre vi era solo la nobiltà semplice32. Di conseguenza, tutti coloro che ambivano alla nobiltà generosa dovevano riuscire a farsi iscrivere in una delle città patrizie, innescando una gara al rialzo tra i lignaggi più antichi per non vedersi soggetti a un pur relativo declassamento, tutto interno alla gerarchia nobiliare. In molti, pur di ottenere il prestigioso titolo, non ricusarono di sottoporsi a un doppio processo di ammissione e, in particolare, l’aggregazione al patriziato fiorentino restò un segno di distinzione perseguito da casati già iscritti in precedenza alla nobiltà, e talvolta persino al patriziato, di una città periferica33.
25Il riconoscimento del patriziato risultò invece problematico per le famiglie di rango aristocratico, ma non toscane, che si erano trasferite nel granducato in una città priva del rango patrizio o da meno di due secoli, e che si videro costrette a subire un degradamento intollerabile rispetto alla condizione di partenza. Tra i molti esempi in questo senso, si segnalano gli Sproni, giunti in Toscana a inizi Seicento da Anversa seguendo fiorenti attività mercantili, che pretesero l’ammissione al rango patrizio di Pisa, anziché a Livorno, ove risiedevano, di nobiltà semplice34. Meno fortuna ebbero i lorenesi Pelletier de Berminy, iscritti alla nobiltà livornese dopo aver richiesto invano l’ascrizione al patriziato fiorentino35. In altri casi non restò altra soluzione che aspettare: così i Goti, aspiranti al grado della nobiltà generosa senese «come famiglia venuta da Stato forestiero», ma senza poter attestare due secoli di residenze nella prima magistratura, non volendo accettare il grado di nobiltà semplice attesero quarant’anni per iscriversi finalmente al rango loro spettante36. La mancata registrazione nei libri d’oro: quale declassamento?
26La legge del 1750 prevedeva espressamente che i sudditi non descritti nei registri della nobiltà o del patriziato «non fossero, né dev[essero] reputarsi nobili, non ostante qualsivoglia sentenza, privilegio, godimento d’onore o consuetudine» potessero addurre37, sancendo un principio di normalizzazione giuridica dello status privilegiato superiore a qualsiasi altro principio nobilitante.
27Ciò nonostante, di fronte a casati di evidente condizione nobiliare ma privi del possesso di prove ammissibili, fu la Deputazione ad escogitare stratagemmi atti a sanare situazioni di indubbio prestigio sociale. In più di un caso emerse infatti una spiccata difformità tra i titoli che la legge riconosceva come probatori del possesso di rango, e quelli che invece la tradizione locale considerava tali. Tra le giustificazioni addotte, ma giudicate irrilevanti ai fini della registrazione, apparvero veri e propri capisaldi della nobiltà toscana quali la titolarità dell’antica cittadinanza fiorentina, l’aver contribuito alla fondazione di cappelle, l’ammissione a una Accademia nobiliare e l’aver ricevuto donazioni dotali da parte di una granduchessa38.
28Volendo esaminare in che misura la legge del 1750 causò declassamento vero e proprio, cioè l’estromissione dal ceto nobile da parte di chi, prima della norma, ne faceva parte, più che sulle esclusioni occorre soffermarsi su chi non fu ascritto, magari per non essersi presentato all’esame della deputazione, volontariamente o per errore. Si trattò di un’evenienza tutt’altro che rara, ma non sempre la mancata registrazione si trasformò in uno stigma sociale come auspicato dalla riforma.
29Le notizie che circolavano nelle settimane precedenti all’entrata in vigore della legge, riferite anche dai rappresentanti stranieri presenti sul territorio, offrono un utile indizio del sentire comune rispetto alla nuova disciplina. Il console della Repubblica di Venezia riportò le preoccupazioni dei «moltissimi» che temevano di restare esclusi in conseguenza di quella «separazione dei nobili dai patrizi», e per la quale si prevedeva una «opera assai lunga per le prove che [sarebbero stati] obbligati a fare»39. L’incaricato d’affari di Madrid a Firenze segnalava una «confusione ogni giorno crescente» quanto al progetto di «dividere in due classi tutta la nobiltà», e le innumerevoli lamentele a fronte delle salate imposte di bollo prevedibilmente necessarie per confezionare le provanze richieste40. Sulla stessa linea, il console spagnolo a Livorno scriveva che la nuova legge dava «molta materia alla discussione»41. Ancora nei primi mesi del 1752, quando la deputazione stava completando la raccolta e l’esame dei fascicoli dei casati fiorentini e senesi, cominciò a circolare a Firenze una «nota ideale» degli ammessi e degli esclusi che suscitò diffuso «sconcerto» tra quanti risultarono espunti secondo il «capriccio» dell’anonimo estensore42.
30Quel che è certo è che gli adempimenti richiesti dalla legge sollevarono grande malcontento non solo perché la documentazione «in carta bollata» era particolarmente onerosa, ma anche perché i diretti interessati «non vedono quali vantaggi siano per riportarne»43. La deputazione inviò più di un sollecito minacciando «la pena di non esser più considerati nobili» in caso di mancate provanze44, senza riuscire a vincere una certa indifferenza, se non un’aperta ostilità, al rispetto della legge. L’eventuale non inclusione parve insomma non così grave a fronte della certezza di godere comunque del riconoscimento sociale da parte della propria comunità di riferimento. Una percezione che sarebbe stata destinata a cambiare.
31Dalla fine del secolo cominciarono infatti a presentarsi famiglie che imploravano l’ascrizione ai libri d’oro di città ove l’opera di registrazione si era conclusa da tempo, adducendo le motivazioni più disparate a giustificazione di quel ritardo. Nei fascicoli ottocenteschi non è insolito imputare la causa della tardiva registrazione all’aver avuto «per antenato qualcuno che stimò atto vile l’obbedire alla legge del 1750 e produrre i suoi titoli, ossia vero da taluno ch’era a quel tempo non ricco e privo del censo necessario per vivere col decoro conveniente al grado nobile»45. L’impossibilità a sostenere il costo per provare la nobiltà, e ancor più nel caso del patriziato, aveva indotto alcuni a chiedere prima l’aggregazione alla nobiltà semplice e solo in un secondo momento a rivendicare la condizione patrizia.
32Col passare del tempo, anche i più riottosi si videro costretti ad appellarsi alla grazia sovrana per mettere a norma il proprio status ed evitare i «non lievi disgusti» cui si vedevano soggetti sempre più spesso per essere esclusi dai libri nobiliari. Tra gli effetti più gravi vi era quello di non poter più assicurare matrimoni di rango alle figlie, cosa che accadde a più di una delle famiglie «sempre state considerate e trattate come nobili», nonostante il possesso di «opulento patrimonio», ma prive della debita registrazione46. Effetti a lungo termine: la «degradazione della classe»
33Nel settembre del 1807, con l’invasione della Toscana da parte delle truppe francesi e l’annessione al Regno napoleonico, la legge del 1750 fu abolita e la nobiltà soppressa. Moltissimi registri, come nel caso di Prato, Pontremoli e San Miniato, andarono distrutti o bruciati47. La condizione economica di gran parte della vecchia aristocrazia subì un ulteriore impoverimento, oltre a diventare «sorvegliata speciale» delle autorità francesi: il prefetto del dipartimento dell’Arno fu incaricato dal ministero dell’Interno di formare, con il massimo riserbo e nel rispetto del «diritto alla vergogna», liste di «ex-nobili poveri», in stato di mendacità, ai quali assegnare un sussidio48.
34Nel luglio 1816, con la restaurazione degli Asburgo-Lorena, i lavori della deputazione ripresero e i libri d’oro ripristinati. Oltre al declino economico, si dovette allora affrontare anche il crollo demografico. Il fenomeno era noto fin dai primi del Settecento e interessò soprattutto i lignaggi di più antica stirpe, in particolare di quelli affermatisi in età repubblicana49. Un documento del 1716, basato sulla documentazione del Magistrato dei Nove, indicava un depopolamento pari a un terzo degli abitanti del granducato in un secolo e mezzo: trecentomila anime in totale, e tremila famiglie nobili mancavano all’appello, tra «mancate e disperse», cinquecento nella sola Firenze50. Dati altrettanto eloquenti furono registrati anche dal celebre erudito Giovanni Antonio Pecci per il caso senese, nel 176451. Nei decenni finali del secolo, i libri d’oro apparivano ormai «ripieni solo di morti», come ebbe a scrivere un magistrato cittadino. Era a rischio la sopravvivenza stessa del ceto. Le modalità di aggregazione alla nobiltà furono pertanto riviste, aprendo a soggetti del rango cittadino. Non si trattò solo di favorire la mobilità sociale, ma di modificare i requisiti costituivi l’identità nobiliare. Dalla metà degli anni Venti dell’Ottocento, e in alcune località come Arezzo, San Miniato, Colle Val d’Elsa, ma anche nella Livorno decimata dall’epidemia di colera del 1831, la situazione divenne così grave da non avere più candidati per i seggi riservati ai nobili degli uffici pubblici. Le Comunità ricorsero quindi alla nobilitazione di «persone collocate in eminenti dignità e primi impieghi infra i cittadini distinti per antica cittadinanza o per cospicua fortuna, e intra i primari commercianti che – benché di estera nazione – alle qualità personali riuniscono importanti possessi»52. La documentazione attesta, dagli anni Trenta, numerose suppliche per svolgere attività professionali in contemporanea alla richiesta di riconoscimento, o alla conservazione del grado nobiliare, tutte accolte positivamente dalla Deputazione e dal granduca53.
35Nel giro di poco più di una decade questo fenomeno di nobilitazione «al ribasso» appare esteso a buona parte del granducato. Nel 1845, il gonfaloniere di Prato considerava «conveniente» «elevare al ceto nobile quei soggetti che per titolo di famiglia o per meriti personali si distinguono a maggior lustro della patria», non foss’altro che per sopperire alle più antiche famiglie che erano «notabilmente diminuite per cause di estinzione di alcune, e decadenza di fortuna di altre»54. Lo stesso accadeva a Colle Val d’Elsa, ove il numero dei casati nobili era «quasi che deperito» per «estinzione» o «per espatriazione». Per l’aggregazione al primo ordine bastava ormai «il trattamento civile», il «requisito del possesso», il non aver «giammai dato motivo a lamenti nei rapporti politici» e un «contegno sociale […] qual si conviene a individui di una classe distinta […], quantunque manchi la caratteristica della nobiltà»55. La Deputazione accolse che il semplice possesso del grado della cittadinanza e l’essere «provvedute di conveniente patrimonio», ovvero «il comodo stato di fortuna e la lodevole condotta», fossero i «due soli requisiti [che] sogliono valutarsi bastanti perché taluno venga considerato degno di conseguire la nobilitazione»56. Insomma, il grado della nobiltà semplice e quello della cittadinanza videro un progressivo avvicinamento fino a non distinguersi quasi più. In alcune città più piccole, l’uso strumentale di queste promozioni favorì l’aggregazione di chiunque desiderasse ottenere onorificenze e titoli, anche senza particolari legami con il territorio. A Fiesole, delle 108 famiglie registrate alla nobiltà a fine anni Cinquanta solo una vi risiedeva; a Modigliana, delle 18 famiglie solo tre erano originarie del luogo; così come a Pietrasanta, tre delle quattro casate registrate erano forestiere giacché «le antiche famiglie nobili del paese non si curano di esservi descritte nel timore probabilmente di degradarsi», preferendo aggregarsi ai più prestigiosi libri d’oro pisani.
36Una variazione significativa alla legislazione nobiliare fu proposta alla Deputazione nel 1857 dal prefetto di Lucca, nell’auspicio di un possibile amalgama con la normativa dell’ex ducato, annesso al granducato dieci anni prima. La Deputazione tardò due anni a rispondere, formulando poi un rapporto complessivo sull’efficacia della legge del 1750 alla luce della «indole mutata dei tempi». L’affare rimase irrisolto, ma le riflessioni dei deputati, nell’imminenza dell’unificazione, risultano di grande interesse. Parti del disposto originario furono giudicate ormai superate: ad esempio, laddove l’art. I definiva nobile chi fosse stato abile, o avesse riseduto, nel gonfalonierato (la più alta magistratura cittadina), la deputazione osservava che se «in antico» tale residenza era riservata alla nobiltà, oramai «per ottenerla basta[va] aver possessi». Non volendo certo il legislatore ammettere per nobili tutti i possidenti, si suggeriva di condizionare l’accertamento della nobiltà «per giustizia» alla discendenza di chi avesse riseduto prima del 1750 (o del 27 aprile 1826, anno di emanazione dell’analoga norma borbonica, per l’ex-ducato lucchese), escludendo «quelle famiglie che [avessero] derogato» dalla nobiltà con l’esercizio di arti vili o non avessero mantenuto il «dovuto splendore». Nel caso della nobiltà «per grazia», invece, si confermavano i requisiti fissati a suo tempo: il domicilio in città, la condizione civile e rendite sufficienti a vivere «decorosamente». Quanto a quest’ultimo aspetto, i deputati riproposero l’utilità di fissare un «censo minimo», poiché «il perpetuare una nobiltà mendica o quasi equivale[va] alla degradazione di questa classe». Inoltre, si prospettò di attribuire al sovrano la potestà di conferire la nobiltà alla luce di «meriti personali, alti impieghi, servigi prestati al principe ed alla patria», equiparando i requisiti di censo proposti per la nobiltà «per grazia» a quelli richiesti per la «classe dei cittadini»57. Si profilava così una nobiltà di servizio, onoraria, ormai pressoché indistinguibile dal grado cittadino.
Conclusioni
37L’opera ordinatrice condotta dalla Deputazione si scontrò contro l’impossibilità di imporre dall’alto il riconoscimento o meno della condizione nobiliare e di modificare, in modo artificiale, la preesistente percezione sociale che tale status presupponeva, fortemente radicato com’era in un patrimonio di storia e tradizioni locali anche molto disomogenee. Questa eterogeneità, difficile da ricondurre a uno standard condiviso, si rispecchiava anche nella molteplicità dei simboli di distinzione e appartenenza. Tra questi, il più controverso fu senz’altro quello relativo al patrimonio. Nonostante restasse un requisito necessario ad assicurare condizioni di vita more nobilium, non poté diventare mai un elemento inequivocabile per valutare il prestigio sociale, né la sua insufficienza causa di declassamento.
38Più incisivi furono invece gli interventi per mitigare l’assottigliarsi numerico del ceto. Nuovi soggetti vennero proposti dalle autorità locali per reintegrare gli esangui ranghi, anche in relativa autonomia rispetto all’egemonia centralizzata della «monarchia amministrativa» di età risorgimentale. Alla prova dei fatti, le infornate degli anni Trenta e Quaranta aprirono inediti spazi di governo a quanti corrisposero ai valori della società ottocentesca, nel rispetto dei principi di ortodossia politica imperante. Con il mutare delle condizioni di costruzione oligarchica, il «problema del declassamento» passò dall’indicare il discredito sociale dovuto a matrimoni ineguali o all’esercizio di professioni indegne, alla difficoltà di non poter più contare su di un numero sufficiente di soggetti in grado di gestire la cosa pubblica con competenza e, magari, anche di offrire al territorio opportunità di crescita economica e sviluppo. In questa chiave, si assisté a un progressivo avvicinamento, fino quasi alla sovrapposizione, dei tre gradi di patriziato, nobiltà e cittadinanza, all’insegna della costruzione di un’unica categoria notabiliare, dotata dei diritti politici, e con dinamiche di decadenza per ragioni altre e con modalità proprie. L’antica nobiltà civica, anima dell’aristocrazia urbana granducale, divenne nobiltà civile, la virtù fu sostituita dalla lealtà patriottica, ispirata a un senso di utilità proficuo per la collettività, e agli antipodi dei fasti del vivere more nobilium.
39Nel 1861, all’indomani dell’unificazione, i componenti della deputazione espressero un giudizio a dir poco severo sugli effetti della legge del 1750, una «pratica introdotta sotto il governo lorenese, da cui tenevasi in dileggio la classe nobile», che aveva relegato i deputati a «considerarsi soltanto […] destinati a contentare la facile ambizione di qualche vecchio strumento del dispotismo perché gli era così aperto l’adito di condurre ai reali festini la moglie ed i figli», senza poter verificare i requisiti di censo o civiltà dei natali, ma limitandosi a verificare se il pretendente la nobiltà «ave[sse] ciecamente obbedito, nel bene e nel male, a questo o a quello dei Ministri, nell’essere dichiarato assiduo frequentatore delle Chiese e dei sacramenti, e nella dichiarazione della Prefettura che il candidato sentiva bene in politica»58. La deputazione chiudeva così amaramente il proprio compito prima di essere soppressa ufficialmente il 26 maggio 1869, e sostituita dalla Consulta araldica del Regno d’Italia59. Bibliographie
Aglietti 2000 = M. Aglietti, Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di Toscana (1750) tra magistrature civiche, Ordine di Santo Stefano e diplomi del principe, Pisa, 2000.
Aglietti 2008 = M. Aglietti, Nobiltà periferiche in Toscana tra Sette e Ottocento. Il caso di Colle Val d’Elsa, in Colle Val d’Elsa e l’Ordine di Santo Stefano. Istituzioni, economia e società, Pisa, 2008, p. 30-66.
Aglietti 2009a = M. Aglietti, Un’illusione per status. L’inferiore nobiltà delle donne nella Toscana dei Lorena in Ead. (a cura di), Nobildonne, monache e cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano. Modelli e strategie femminili nella vita pubblica della Toscana granducale, Pisa, 2009, p. 97-120.
Aglietti 2009b = M. Aglietti, I Governatori di Livorno dai Medici all’Unità d’Italia. Gli uomini, le istituzioni, la città, Pisa, 2009.
Aglietti 2012 = M. Aglietti, L’istituto consolare tra Sette e Ottocento. Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale, Pisa, 2012.
Aglietti 2014 = M. Aglietti, «Riconoschiamo nobili essere tutti quelli che posseggono o hanno posseduto feudi nobili». La legge del 1750 e gli effetti sulle nobiltà feudali del Granducato di Toscana, in Ricerche Storiche, 2-3, 2014, p. 41-55.
Aglietti 2015 = M. Aglietti, La nobiltà feudale nel Granducato di Toscana tra Sette e Ottocento: norme, caratteri, rappresentazione, in R. Cancila e A. Musi (a cura di), Feudalesimi nel Mediterraneo, I, Palermo, 2015, p. 165-184.
Baker 1972 = G.R.F. Baker, Nobiltà in declino: il caso di Siena sotto i Medici e gli Asburgo-Lorena, in Rivista Storica Italiana, LXXXIV, 1972, p. 584-616.
Burr Litchfield 1969 = R. Burr Litchfield, Caratteristiche demografiche delle famiglie patrizie fiorentine dal Sedicesimo al diciannovesimo secolo, in Saggi di demografia storica, Firenze, 1969, p. 17-34.
Kroll 2005 = T. Kroll, La rivolta del patriziato. Il liberalismo della nobiltà nella Toscana del Risorgimento, Firenze, 2005.
Cantini 1806 = L. Cantini, Legislazione Toscana raccolta e illustrata, XXVI, Firenze, 1806.
Chiavistelli 2006a = A. Chiavistelli, Dallo Stato alla nazione. Costituzione e sfera pubblica in Toscana dal 1814 al 1849, Roma, 2006.
Chiavistelli 2006b = A. Chiavistelli, Il Comune di Pietro Leopoldo: il Regolamento per la Comunità di Firenze del 20 novembre 1781, in Annali di storia di Firenze, I, 2006, p. 181-206.
de’ Rossi 1781 = F. de’ Rossi, Considerazioni morali, economiche e politiche, scritte nell’Anno 1764, in Francisci Rossi iuriconsulti florentini Monumenta posthuma latina et italica, Firenze, Ex Typographia Bonducciana, 1781.
Labardi 2013 = A. Labardi, Un’istituzione della Toscana lorenese: la Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza, in Le Carte e la Storia, 1, 2013, p. 39-63.
Marrara 1976 = D. Marrara, Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII, Pisa, 1976.
Mannori 1994 = L. Mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nella Toscana dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, 1994.
Panicucci 1998 = E. Panicucci, Alcune osservazioni sul notariato nel Settecento toscano, in Ricerche storiche, 1998, p. 23-62.
Rossi 2009 = C. Rossi, Interpretazioni controverse della legge nobiliare toscana del 1750. Ordine di Santo Stefano e città nobili in alcune memorie inedite dell’età della Reggenza, in D. Barsanti (a cura di), Omaggio a Rodolfo Bernardini, Pisa, 2009, p. 209-244.
Rossi 2011 = C. Rossi, Nobili, patrizi e cavalieri. Contributi alla storia dei ceti dirigenti toscani nel Settecento, Pisa, 2011.
Rossi 2015 = C. Rossi, Giovanni Antonio Pecci e i suoi scritti sulla nobiltà senese, Pisa, 2015.
Rossi 2018 = C. Rossi, Le città nobili della Toscana granducale (secoli XVII-XVIII), Pisa, 2018.
Ruiu 2009 = A. Ruiu, La famiglia Sproni fra Comunità di Livorno, Ordine di S. Stefano e nobiltà toscana: l’ascesa di una nuova aristocrazia, in Nuovi Studi Livornesi, XVI, 2009, p. 97-119.
Sordi 1991 = B. Sordi, L’amministrazione illuminata. Riforma delle comunità e progetti di costituzione nella Toscana leopoldina, Milano, 1991.
Sordi 1995 = B. Sordi, La riforma leopoldina delle comunità tra modelli progettuali e realizzazioni concrete, in L’Ordine di S. Stefano e la nobiltà toscana nelle riforme municipali settecentesche, Pisa, 1995, p. 17-27.
Tanti 1992 = G. Tanti, Per una riflessione sul declino della nobiltà in Toscana: i soccorsi agli ex-nobili poveri a Pisa in età napoleonica, in L’Ordine di Santo Stefano nella Toscana dei Lorena, Roma, 1992, p. 326-337.
Verga 1990 = M. Verga, Da «cittadini» a «nobili», lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano, Milano, 1990. Notes de bas de page
1 Nell’impossibilità di una rassegna esaustiva, vedasi almeno Marrara 1976; Mannori 1994; Verga 1990; Kroll 2005; Chiavistelli 2006a; Aglietti 2008 e 2015; Rossi 2011.
2 Il testo, e il decreto di attuazione (cioè l’Istruzione alli Deputati sopra la descrizione della nobiltà), in Cantini 1806, p. 231-241 e 246-280. Sulla norma: Verga 1990; Aglietti 2000 e 2014; Rossi 2009.
3 Labardi 2013, p. 39-45.
4 In estrema sintesi, la legge prevedeva che nei centri urbani del granducato riconosciuti come « città » si compilassero dei registri dove iscrivere le famiglie nobili residenti. Su questo punto, Rossi 2018, p. 34-38.
5 I fascicoli relativi agli «Affari sospesi» dal momento di avvio della legge al 1822 sono raccolti in Archivio di Stato di Firenze (oltre ASFi), Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza (oltre Deputazione), da 135 a 141, e ivi, 142, per gli anni dal 1816 al 1864.
6 ASFi, Deputazione, 122, c. 32v-33r, lettera della Deputazione inviata al governatore di Pistoia e ai referenti pubblici presso le città di Cortona, Pisa, Arezzo, Volterra e Pistoia, il 28 marzo 1753.
7 Ibid., c. 82r, i deputati al commissario di Pisa, il 9 aprile 1767, e altra analoga, c. 98r-v, al vicario di San Sepolcro, 12 aprile 1786.
8 Ibid., c. 66r-67r, rapporto della deputazione all’auditore generale di Siena del 15 giugno 1756 nel quale si offre un riepilogo esaustivo delle ragioni della sospesa ammissione di ben 14 famiglie, poi tutte iscritte meno una, gli Ariosti.
9 Così, dei senesi Ciogni e Nini, complici e condannati per peculato, nulla si trova nel fascicolo familiare del primo, per altro contumace, mentre l’altro, al confino all’epoca della richiesta, appare indicato in quanto capostipite della famiglia. Entrambi i casati furono ammessi al patriziato senese; in ASFi, Deputazione, 122, c. 43v, i deputati all’auditore generale di Siena del 29 gennaio 1754 e ivi, 23, ins. 37.
10 Ibid., 139, ins. 1, Affari sospesi, istanza reiterata per cinque volte dalla (presunta) baronessa Ernesta D’Eisenberg, vedova Fabrini, per il patriziato fiorentino. La proposta di rilascio di un decreto negativo è del 1782.
11 Così capitò a un livornese che, pur riconosciuto idoneo alla nobiltà di Pisa, non poté goderne gli effetti finché la sua promessa sposa, abbandonata sull’altare, non convolò a nuove nozze, undici anni dopo, ASFi, Deputazione, 63, ins. 16 e ivi, 122, c. 134r.
12 Rossi 2018, p. 38-39.
13 Aglietti 2000, p. 88-92. Sul punto, si espresse negativamente nel 1806 anche il giurista Lorenzo Cantini che, alla legge del 1750, dedicò uno scritto critico, cfr. Rossi 2011, p.161- 180. Sulla professione notariale in Toscana, Panicucci 1998, p. 23-62. Solo nel 1790, un apposito provvedimento granducale rese il notariato compatibile con la condizione nobiliare.
14 ASFi, Deputazione, 122, c. 6v, rapporto al granduca del 22 marzo 1751.
15 Aglietti 2012, p. 282-292.
16 de’ Rossi 1781, p. 149-150.
17 Relazione dei deputati, a firma del presidente Orlando del Benino, del 12 febbraio 1805, in ASFi, Deputazione, 74, ins. 4.
18 Ibid., c. 100v-101v, rapporto dei deputati e rescritto granducale d’approvazione, 2 giugno 1786.
19 Archivio di Stato di Pisa (d’ora in poi ASPi), Ordine di Santo Stefano, 2922, motuproprio del 3 maggio 1753.
20 ASPi, Ordine di Santo Stefano, 2922, lettera dell’auditore dell’Ordine del 14 gennaio 1789.
21 La riforma della Comunità toscane, voluta dal granduca Pietro Leopoldo Asburgo Lorena, assicurò l’accesso alle magistrature locali ai rappresentanti dei possessori di beni stabili, affiancandoli alle rappresentanze nobiliari. Oltre a Sordi 1991, p. 283-291 e Sordi 1995, anche Chiavistelli 2006b, p. 181-206.
22 ASFi, Deputazione, 119, c. n.n., rapporto al granduca, 18 agosto 1795.
23 Ibid., 140, c. n. n., Affari sospesi, relazione di alcuni nobili di San Sepolcro del maggio 1795.
24 Delle varie edizioni degli statuti, si cita qui quella definitiva: Statuti dell’Ordine de’ Cavalieri di Santo Stefano ristampati con l’addizioni de’ Serenissimi Cosimo II e Ferdinando II e della Sacra Cesarea Maestà dell’Imperatore Francesco I Granduchi di Toscana e Gran Maestri, Pisa, Bindi, 1746, in particolare titolo II, capitolo III, p. 95.
25 ASPi, Ordine di Santo Stefano, 2922, rescritto magistrale del 23 settembre 1786.
26 Per Siena, cfr. ASFi, Deputazione, 122, c. 37r-38v, lettera del 14 luglio 1753 e informativa da Firenze del 28 agosto successivo; per Pisa, ivi, c. 46r e 52v-53r del 18 ottobre 1754.
27 Per un esame sulle presenze femminili nei libri d’oro della nobiltà toscana cfr. Aglietti 2009a.
28 ASFi, Deputazione, 89, ins. 4 e 1.
29 Ibid., ins. 2.
30 Ibid., 113 bis, relazione del 13 dicembre 1858.
31 ASFi, Deputazione, 122, c. 156r-v, regolamento per l’ammissione delle donne al Casino dei nobili di Pistoia; alle c.160v-161r, rapporto sulla questione al granduca del 12 gennaio 1791 e, alle c.162v-163r, circolare del 18 febbraio 1791 e ordine sovrano del 31 gennaio.
32 Sul concetto di città « nobile », Rossi 2018, p. 43-82.
33 Chiesero una seconda aggregazione ai libri d’oro fiorentini molti dei casati già registrati e residenti a Pisa, Arezzo, Pistoia, Volterra, Cortona e Colle Val d’Elsa. In quest’ultima, oltre un terzo dei registrati chiesero la doppia ascrizione, in Aglietti 2008, p. 40-41.
34 ASFi, Deputazione, 28, ins.8. Sul caso Sproni, Ruiu 2009, p. 97-119. Livorno fu innalzata al rango di « città patrizia » solo nel 1816, in Aglietti 2009b, p. 257-264.
35 Ibid., 64, ins. 12. La famiglia fu ammessa alla nobiltà livornese il 3 luglio 1789.
36 Ibid., 122, c. 43r, rapporto all’auditore generale di Siena del 29 gennaio 1754 e ivi, 68, ins. 12.
37 Ibid., c. 144v, rapporto al granduca del 17 luglio 1789, con riferimento agli articoli 14 e 16 della legge.
38 Una rassegna esaustiva in Aglietti 2000, p.148-156.
39 Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savi alla Mercanzia, I serie, 702, Sebastiano Vichi, console di Venezia a Livorno, il 17 e 24 ottobre, e 6 novembre 1750.
40 Archivo General de Simancas, Estado, 7794, Ranieri Vernaccini, incaricato d’Affari di Madrid a Firenze, li 10 ottobre 1750, lettera al sovrano. Traduzione mia.
41 Ibid., 5393, lettere del console spagnolo a Livorno, Odoardo de Silva, 8 ottobre 1750. Traduzione mia.
42 ASFi, Deputazione, 122, c. 18r, al conte Pandolfini, il 13 marzo 1752.
43 Archivio di Stato di Venezia, Cinque Savi alla Mercanzia, I serie, 702, Sebastiano Vichi, console di Venezia a Livorno, li 11 dicembre 1750.
44 ASFi, Deputazione, 122, c. 11v, rapporto al granduca del 6 settembre 1751.
45 Ibid., 151, ins. n. n., Rapporto a Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno sullo stato della Deputazione sopra la nobiltà, redatto dalla segreteria della Deputazione, il 1° settembre 1861.
46 Fu il caso, ad esempio, dell’auditore Francesco Cheluzzi, che implorò la nobiltà per giustizia per il bene della figlia solo nel 1816, in ASFi, Deputazione, 76, ins. n.n.
47 Ibid., 172, c. 244r-v.
48 Per il caso della città di Pisa, Tanti 1992, p. 326-337.
49 Vedasi gli ancora validi Burr Litchfield 1969, p. 17-34; e Baker 1972, p. 584-616.
50 ASFi, Archivio Antinori, 25, ins. 288, relazione del marchese Bartolini in data 3 marzo 1716.
51 Dei 125 casati nobili senesi ancora viventi (senza contarne le diramazioni) ben 17 non erano più idonei a risiedere negli uffici cittadini per essersi trasferiti o per altre ragioni (immiserimento, esercizio di attività vili, delitti di peculato, matrimoni ineguali e anche casi di malattie mentali), così Pecci, Lettera sull’antica, e moderna derivazione delle famiglie nobili di Siena, in Rossi 2015, p. 48.
52 Per il caso aretino, ASFi, Deputazione, 81, ins. 10 (rapporto del 1825); per quello sanminiatese, ivi, 87, ins. 2 (rapporto del 1829); per Livorno, vedi la lettera del gonfaloniere al granduca del 19 gennaio 1836, in ivi, 93, ins. 14.
53 Riepilogo al granduca, del 6 ottobre 1835, riferente anche a casi simili a San Miniato nel 1830 e a Volterra, nel 1833, in ASFi, Deputazione, 92, ins. 9.
54 Ibid., 106, ins. 14.
55 Ibid., ins. 2.
56 Rapporti al granduca del 8 ottobre 1844, in ivi, 105, ins. 10 bis, e del 17 aprile 1845, in ivi, 106, ins. 2.
57 ASFi, Deputazione, 151, ins. n. n., Affare relativo alla proposta variazione della legislazione vigente in materia di nobiltà. (Non risoluto).
58 ASFi, Deputazione, 151, ins. n. n., Rapporto a Sua Eccellenza il Ministro dell’Interno sullo stato della Deputazione sopra la nobiltà, del 1° settembre 1861.
59 Labardi 2013, p. 60-63.
Auteur Marcella Aglietti
Università di Pisa - marcella.aglietti@unipi.it